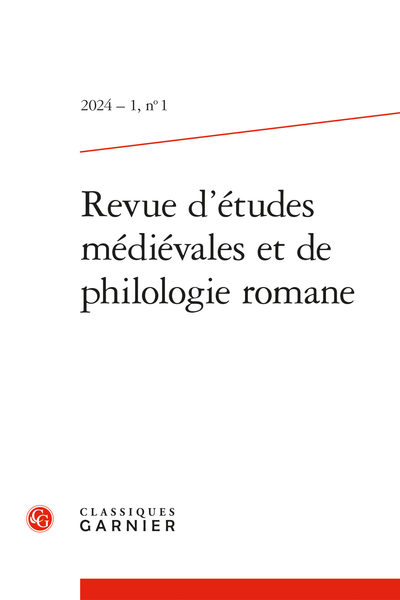
Una citazione, un sillogismo, un leixa-pren Ricordo di Anna Ferrari (Modena, 30 vi 1944 – Roma, 2 viii 2023)
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’études médiévales et de philologie romane
2024 – 1, n° 1. varia - Auteur : Barberini (Fabio)
- Pages : 211 à 232
- Revue : Revue d’études médiévales et de philologie romane
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406167136
- ISBN : 978-2-406-16713-6
- ISSN : 3037-0000
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16713-6.p.0211
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 21/02/2024
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Italien
Una citazione, un sillogismo,
un leixa-pren
Ricordo di Anna Ferrari
(Modena, 30 vi 1944 – Roma, 2 viii 2023)
Anna Ferrari era nata a Modena, la città del Duomo di Lanfranco e di Wiligelmo, con la Porta della Pescheria e le Arturi regis ambages pulcerrimae istoriate nel marmo dell’archivolto; la città della Biblioteca Estense e dei Canzonieri provenzali D ed a (il Liber Domini Alberici e il ‘Complemento Càmpori’); la città dei grandi maestri della Filologia Romanza (Giulio Bertoni e Aurelio Roncaglia) e dei loro antichi precursori (Giovanni Maria Barbieri, Ludovico Castelvetro e Carlo Sigonio). E della sua nascita modenese era, et pour cause, molto fiera, come ebbe a ribadire in un’intervista raccolta da Henrique Monteagudo nel 1990: «nacín en Módena, como moitos filólogos romanistas, alí teño unha tradición boa. Polo tanto, de nacemento son boa» (Ferrari, 1990 [2022], p. 187). Conseguita la maturità liceale al «Lycée Chateaubriand» di Roma – città in cui la famiglia, senza mai recidere i legami con la natia Emilia, si era stabilita subito dopo la fine della Guerra –, si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell’Università «la Sapienza» dove compì la sua formazione nella scuola di romanistica fondata da Ernesto Monaci e che, negli anni ’60 del secolo scorso, faceva capo all’allora «Istituto di Filologia Romanza» diretto da Aurelio Roncaglia. Sotto la guida esigente e rigorosa di Roncaglia, Anna Ferrari elaborò la sua Tesi di laurea sul trovatore Bernart de Ventadorn, discussa nel 1968.
Nell’Ateneo romano, la giovane studiosa compì anche le prime tappe della carriera accademica, prima come assistente e poi come professore associato1. Redattore di Cultura Neolatina dai primi anni ’70, partecipò 212sempre attivamente al funzionamento della Rivista – tra il 1972 e il 1983 redige per lo Schedario una sessantina di schede (in alcuni casi vere e proprie recensioni) relative per lo più (ma non solo) a titoli di provenzalistica e francesistica medioevali2 – e, insieme a Saverio Guida e Roberto Crespo, ne assunse la Direzione nel 2001 (dopo la scomparsa di Roncaglia), occupandosi, come avrebbe detto Carolina Michaëlis de Vasconcellos, «con paixão e paciência» di tutte le fasi del lavoro editoriale, dai dattiloscritti degli autori (si dirà, oggi, files word) fino alle ultime bozze di tipografia. Raggiunto il grado di professore ordinario all’inizio degli anni ’90, si trasferì all’Università dell’Aquila, dove rimase fino alla sua uscita dai ranghi universitari, avvenuta nel 2014, e dove, grazie al suo vasto dominio del settore romanzo, oltre ai corsi del proprio settore scientifico-disciplinare, tenne per più di due decadi anche corsi di Letteratura Francese, Storia del Teatro Francese e, soprattutto, di Letteratura Portoghese. In quest’ultimo settore avviò una lunga e proficua collaborazione con l’Ambasciata portoghese in Italia, l’«Istituto Camões» e la Facoltà di Lettere dell’Università di Lisbona (FLUL) che portò a L’Aquila, in qualità di visiting professors, i maggiori specialisti di letteratura lusitana del Medioevo e del Rinascimento: Maria Idalina Resina Rodrigues, Isabel de Almeida, João Dionísio, Maria Vitalina Leal de Matos, Teresa Amado.
Membro attivo delle più importanti associazioni scientifiche internazionali, aveva fatto parte della Junta directiva della «Asociación Hispánica de Literatura Medieval» (AHLM), di cui era stata nominata anche «miembro de honor», e tra, il 1999 e il 2011, aveva ricoperto la carica di Vicepresidente dell’«Association Internationale d’Études Occitanes» (AIEO).
Studiosa particolarmente attenta alla lirica romanza delle origini, Anna Ferrari ha dedicato gran parte delle sue ricerche soprattutto alla 213poesia dei trovatori provenzali3 e alla lirica galego-portoghese e la sua tradizione manoscritta.
In ambito provenzale, e fin dal suo primo articolo, il settore privilegiato d’indagine è stato la tecnica compositiva dei trovatori, con particolare attenzione alla dimensione formale dell’antica lirica in lingua d’oc: artifici retorici e strutture metriche. Gli obiettivi perseguiti sono sempre stati, da un lato, «una più rigorosa storicizzazione e valutazione complessiva della poesia trobadorica» (Ferrari, 1971, p. 172), dall’altro, la risemantizzazione della ben nota etichetta di «poésie formelle» applicata da Robert Guitte alla lirica medioevale. Questo programma di ricerca fu ribadito in due ravvicinate occasioni all’inizio degli anni ’90:
Structures formelles (ce qui ne coïncide que très partiellement avec la «poésie formelle» de Robert Guiette), non pas dans le sens moderne (structuralisme, formalisme) – ou plutôt prémoderne, puisque, Dieu merci, nous en sommes à un stade de la recherche qui a laissé derrière-soi les ‘formalismes formels’ (permettez-moi le jeu de mots), non sans en avoir tiré quelque enseignement, mais sans le fanatisme monothéiste qui a caractérisé ce courant pendant quelques années et qui continue à le caractériser chez certains épigones peu avertis. Il s’agit dans ce cas d’un formalisme bien plus ‘substantiel’, plus ‘architectural’, dirais-je, pour me rapporter au titre brillant d’un ouvrage récent (Ferrari, 1992, p. 879; il riferimento è a Billy, 1989).
L’argomento qui proposto, la parola-rima nella lirica galego-portoghese, inerisce a due diverse linee di ricerca cui da qualche tempo ho dedicato la mia attenzione. Da un lato, il tentativo di individuare gli elementi concreti che differenziano la lirica peninsulare delle origini dalle altre liriche romanze […]. D’altro lato, il desiderio di risemantizzare in una direzione distinta dal filone Guiette – Dragonetti – Zumthor il qualificativo nella felice definizione della lirica romanza delle origini quale «poésie formelle» […]. Ora, a mio avviso, si tratta certo d’una poesia di ‘formule’, ma anche e non meno di ‘forme’ vere e proprie, in primo luogo strutturali, vale a dire metriche, con rilievo particolare accordato agli artifici metrico-retorici inerenti alla rima (Ferrari, 1993c [2014b], p. 61).
214Ed è proprio in questa direzione che si muovono i più brillanti contributi di Anna Ferrari allo studio della lirica trobadorica, fin da quel primo articolo, «Bernart de Ventadorn fonte di Peire Vidal?», ricavato da una mise à point d’un capitolo della sua Tesi di Laurea e pubblicato, nel 1971, in un volume monografico di Cultura Neolatina in omaggio a Jean Frappier. Nella linea tracciata da Roncaglia nello «straordinario articolo» (sono parole di Stefano Asperti, 2017) «su Carestia nel quale vengono messi in opera criteri formali e valutazioni interpretative» e che «può essere a buon diritto considerato come l’antesignano della ricerca sull’intertestualità in ambito lirico», Anna Ferrari – siamo all’inizio degli anni ’70, agli albori del massiccio interesse della critica per le ricerche intertestuali – propone una densa disamina in cui, con dovizia di riscontri puntuali e puntualmente analizzati e interpretati, dimostra la dipendenza tematica e formale di Peire Vidal da Bernart de Ventadorn e, a livello più generale, pone l’accento sull’
importanza dell’imitazione intesa non solo come ossequio a dettami di scuola e occasionale riutilizzazione di un patrimonio in parte già tradizionalmente topico, ma proprio come mestiere ed esercizio specifico di tecnica letteraria, da considerarsi alla stregua dell’esercizio metrico e retorico e parallelamente ad esso: non dunque ricezione passiva di motivi e di formule, bensì loro assunzione consapevole e intenzionale (Ferrari, 1971, p. 171; il corsivo è mio e sostituisce lo spazieggiato dell’originale).
La ventennale riflessione sulle strutture formali della lirica d’oc – non soltanto «formule» ma anche e soprattutto «‘forme’ vere e proprie, in primo luogo strutturali, vale a dire metriche» (Ferrari, 1993c [2014b], p. 61) – troverà compiuta sistematizzazione nei già menzionati interventi su Peire Vidal (Ferrari, 1992) e sulla parola-rima (Ferrari 1993c [2014b]).
Il primo (Ferrari, 1992) – una comunicazione presentata al IIIeCongrès International de l’Association Internationale d’Études Occitanes (Montpellier, 20-26 settembre 1990) – propone una minuziosa analisi della complessa struttura metrico-formale di Molt m’es bon e bell (PC 364.29) e conclude che, contrariamente a quanto avevano sostenuto, in tempi diversi e per ragioni diverse, Alfred Jeanroy, Antoine Tavera e Dominique Billy, «la structure de la pièce» è «fort regulière, sans la moindre imperfection» (Ferrari, 1992, p. 886). L’occasione permette anche di ribadire che, tra le invenzioni formali dei trovatori, la più straordinaria è stata proprio 215quella delle «strutture metriche in movimento», tra le quali però Anna Ferrari è poco propensa ad includere la «sestina», struttura di cui, senza dubbio, né disconosceva, né ridimensionava l’importanza, ma di cui non era certo tra gli estimatori più fervidi ed entusiasti:
malgré son rigide et parfait automatisme, le texte [de Peire Vidal]conserve encore quelque chose de vivant, de pas sclérosé, qui se soustrait au langage ‘aride’ des mathématiques; ce qui n’est déjà plus le cas pour la sextine arnaldienne qui, elle, par l’exhibition trop étalée de sa fixité formulaire déjà toute mécanique (alors que Peire Vidal s’était laissé, dans la fixité, une petite marge: les mots-rime nouveaux à inventer), marque irrémédiablement la déclin de la recherche formelle, qui, elle non plus, n’a plus rien à dire, tout au moins à qui pense – comme je le pense fermement – que c’est le mouvement, plutôt que la fixité, l’élément productif à tous les niveaux”4 (Ferrari, 1992, p. 890).
Il secondo (Ferrari, 1993c [2014b]) – anche in questo caso, una comunicazione congressuale: al convegno O cantar dos trovadores, celebrato a Santiago de Compostela tra il 26 e il 29 aprile del 1993 –, effettua con ampia prospettiva comparatistica e solido impianto positivista un serrato confronto tra trobadors in lingua d’oc e trobadores galego-portoghesi sul terreno dell’artificio metrico-retorico della parola-rima. A partire dall’«invenzione» provenzale di tale artificio, Anna Ferrari propone una prima messa a punto, di metodo e terminologia, in ordine al significato di alcuni espedienti formali, non sempre riconosciuti e descritti correttamente dai compilatori dei repertori metrici e dagli editori dei testi lirici: il mot tornat in rim che, specie in ambito iberico, dev’essere correlato alla fenomenologia dell’hequivocatio; il mot-refrain, da collocare sulla frontiera tra refrain vero e proprio e parola-rima; i legami, in definitiva, tra parallelismo e parola-rima, tra parola-rima e «dobre in rima». In tal senso, sono di particolare rilevanza proprio le osservazioni sull’incidenza di dobre e mozdobre, artifici non di rado fraintesi dagli editori, i quali riconducono sotto queste due etichette anche casi di repetitio alieni alla «duplice costrizione al mantenimento sia della sede stichica all’interno 216della strofe, sia della giacitura all’interno del verso» (Ferrari, 1993c, p. 69). Il raffronto delle due tradizioni liriche permette di rilevare una sostanziale disparità formale ed estetica tra trovatori iberici e trovatori provenzali che si traduce, di fatto, in una diversa tecnica compositiva: mentre le parole-rima dei primi non brillano per originalità – si tratta di vocaboli di assoluta banalità all’interno del sistema lessicale di riferimento e che, nell’articolazione della charpente strofica, ovvero, nella fissità strutturale dell’intera cantiga, reagiscono quasi sempre con altre figure di ripetizione quali anafora, derivatio e (a volte) hequivocatio, quasi a «denunciare il preminente senso dell’unità strofica sull’unità dell’intera canzone» –, le parole-rima dei secondi brillano, invece, proprio per la loro «varietà, rarità e pregnanza» – preziosa, a tal riguardo, l’analisi delle parole-rima adoperate da Marcabru, Bernart de Ventadorn, Raimbaut d’Aurenga e Bertran de Born –, nonché per la complessa dinamica del loro movimento dentro e fuori della strofa, nell’arco dell’intera canzone, in quanto detonatori di raffinate virtuosistiche «sperimentazioni formali». L’equilibrata valutazione dei dati porta quindi a concludere che
il punto d’osservazione privilegiato offerto dalla parola-rima consente di confermare l’impressione, già suggerita da altri fenomeni, che una delle caratteristiche della lirica galego-portoghese sia costituita dal suo elevato livello di staticità. Una caratteristica non necessariamente da intendersi come connotazione negativa, indizio di scarsa perizia tecnica, ma da assumere come segnale di un gusto diverso, meno soggettivo e più oggettuale (Ferrari, 1993c [2014b], p. 83).
Prologo di questo dittico, o più correttamente solido quadro metodologico di riferimento, tanto sul versante teorico come nelle sue applicazioni pratiche, è l’ampio studio sul vers di Grimoart Gausmar, Lanquan lo temps renovelha (PC 190.1) stampato in Cultura Neolatina nel 1991. Come annuncia già il titolo («Rima derivativa e critica testuale») a muovere l’indagine sono, in questo caso, concreti problemi ecdotici, laddove la lezione dei testimoni, C ed e (oggi descriptus di Mh2), deturpava nella strofa seconda la complessa virtuosistica struttura a rime derivative e retrogradatio cruciata del componimento, problemi che Albert Stimming (1873, p. 57), primo editore del vers, non aveva individuato e che erano passati inosservati sia a Roncaglia (1968, p. 61), che aveva riprodotto il testo Stimming in una celebre dispensa di corso universitario, sia a Riquer (1975, I, p. 273), che l’aveva accolto nella sua ancora imprescindibile 217antologia trobadorica. L’edizione del testo è fondata su un accurato esame della sua struttura (ancora una volta una «struttura metrica in movimento») e dei due testimoni che lo conservano (Ferrari, 1991b, p. 121-152), ed è corredata da un ampio commento (ibid., p. 161-190), che rivede e attenua la forte dipendenza dal modello di Marcabru, a suo tempo segnalata da Riquer: «l’influsso marcabruniano è integrato e fortemente mitigato da elementi che risalgono a GlIX, JRud e soprattutto da chiari segni di contatto con BnVent» (ibid., p. 161). Conclude quest’ampia messe di materiali una densa appendice (ibid. p. 191-202) che estende «il discorso – senza tentare affatto per ora di esaurirlo – al mini-corpus di componimenti derivativi, per alcune rapide considerazioni d’insieme» che, con robusto understatement, sono definite «appunti bruti che andranno poi contestualizzati e interpretati; ma che varranno però anche così ad orientare circa la rilevanza del fenomeno derivativo, nel cui contesto si inserisce il componimento [il vers di Grimoart Gausmar] preso in esame» (ibid. p. 191 e nota 48), «appunti» che oggi meriterebbero di essere ripresi e approfonditi.
Alla «lunga fedeltà» professata allo studio dell’inestricabile dialettica tra strutture formali e dimensione estetica non abdicano neppure gli ultimi due contributi trobadorici di Anna Ferrari, dedicati, rispettivamente, a una traduzione d’una strofa di Perdigo eseguita dal rimatore italiano Polo Zoppo da Bologna (Ferrari, 2012) e ai fondamenti ideologici dell’amato Bernart de Ventadorn (Ferrari, 2017).
Il primo contributo (Ferrari, 2012) riprende una comunicazione letta al convegno tolosano dell’AIEO del 1996, ma poi non pubblicata negli Atti5. Con il rigore che ha sempre caratterizzato tutti i suoi interventi, 218Anna Ferrari prende in esame, dalla duplice prospettiva della tecnica di composizione (che, in questo caso, è anche tecnica di traduzione: linguistica e metrica) e delle strutture formali, il sonetto di Polo Zoppo (Ladro mi sembra Amore, poi che fese) e il modello provenzale di cui questo è traduzione, vale a dire la strofa II (Ben fetz Amors l’usatge del lairo, v. 10-18) di Perdigon, Tot l’an mi ten Amors (PC 370.13). Un «esperimento traduttorio», che
costituisce un capitoletto − o quanto meno un paragrafo − significativo nella storia del sonetto: infatti, per quanto l’esperimento sia incentrato su di una traduzione, si tratta però di un caso singolare e significativo, in quanto la traduzione linguistica (il passaggio dall’una all’altra lingua) si coniuga con la traduzione metrica (il passaggio da un genere metrico all’altro), il punto d’arrivo essendo l’ancora misterioso nostro sonetto (Ferrari, 2012, p. 262).
Il secondo contributo (Ferrari, 2017) è una comunicazione presentata alla Trobada Bernard de Ventadour: Folle amour et courtoisie celebratasi aDarnets(nei pressi dello Chateau-Ventadour), tra il 9 e il 10 settembre del 2016. Nell’analisi proposta, dimensione estetica e prospettive etiche – il ruolo centrale di Bernart de Ventadorn nell’elaborazione dell’ideologia cortese e nel trionfo della fin’amor – non sono disgiunte dalla costante attenzione alle strutture formali, in un’appassionante disamina che mostra anche la non immediatamente evidente complessità delle strutture metriche bernartiane (ancora da studiare a fondo): una complessità che lo stesso trovatore dissimula sotto un trobar (apparentemente) leu, cui un’inveterata tradizione critica (che la studiosa contesta con vigore) attribuisce semplicità di ornato e facilità di dettato. Visto oggi, sulla triste eco non ancora sopita della sua scomparsa, sembra quasi che il Destino (o qualunque altra entità metafisica si voglia invocare) abbia concesso ad Anna Ferrari di prendere congedo dal «suo» Bernart de Ventadorn proprio nei luoghi – i ruderi dell’antico castello limosino – in cui il trovatore della lauzeta aveva mosso i primi passi, nella vita e nell’arte.
Da questo breve catalogo, emerge la figura d’una studiosa che coltivava un’idea della Filologia Romanza come disciplina storica di solido impianto 219positivistico e di prospettiva comparativa irrinunciabile, fondata sulla viva coscienza dell’unità del mondo romanzo. L’uno e l’altro elemento procedevano dalla lezione appresa nella «Scuola romana di Filologia Romanza», animata e diretta da Aurelio Roncaglia. All’atteggiamento vigile, di non supino consenso, rispetto alle posizioni di quanti l’avevano preceduta – sempre prese in considerazione ma, all’occorrenza, quasi sempre contraddette e corrette –, si aggiungeva la netta consapevolezza che, per un verso, nessun passo in avanti si può fare nella ricerca senza, preliminarmente, effettuare sondaggi estesi e minuziosi che, soli, possono fornire una ricostruzione affidabile del quadro di riferimento del problema studiato, e, per l’altro verso, che nessuna conclusione, per quanto rigorosa nel ragionamento e solidamente fondata negli elementi che la giustificano, può essere a pieno titolo considerata un punto fermo definitivo, ma che costituisce, semmai, sempre e soltanto un punto d’approdo provvisorio che, a sua volta, servirà come punto di partenza per approfondimenti futuri.
Il medesimo rigore e la stessa esigenza di precisione e chiarezza informano anche gli studi di Anna Ferrari nel settore galego-portoghese che si affiancano, fin dai primi anni della sua attività scientifica, alle ricerche di provenzalistica.
È infatti all’inizio della decade dei ’70 che, grazie a una borsa concessa dal Governo portoghese, Anna Ferrari arrivò a Lisbona. Il progetto iniziale consisteva nell’allestire un’edizione critica del trovatore Johan Lobeira (secondo terzo del s. xiii). Siamo in anni, in certa misura, «fondativi» per la filologia galego-portoghese in Italia. Gli studi di Giuseppe Tavani (1969) sulla tradizione manoscritta avevano sistematizzato in uno stemma codicum – poi fortemente contestato da Jean Marie d’Heur, da Elsa Gonçalves e dalla stessa Anna Ferrari – i dati d’un testimoniale quantitativamente povero, ma ricco invece di problemi estremamente complessi (alcuni ancora oggi irrisolti). In campo ecdotico, gli interventi di Valeria Bertolucci Pizzorusso (1963), dello stesso Tavani (1964a e 1964b) e di Luciana Stegagno Picchio (1969) avevano cominciato ad applicare la metodologia dell’edizione critica monografica anche ai trovatori iberici, fino ad allora oggetto di edizioni complessive per canzoniere e/o per genere (Michaëlis, 1904; Nunes, 1926-1928; Nunes, 1933)6. La progettata – ma mai finita 220– edizione di Johan Lobeira si inseriva dunque in questo contesto, ma a distogliere l’attenzione della giovane filologa dall’iniziale proposito fu proprio l’emozionante incontro con il Colocci-Brancuti (Lisbona, BNP, reservados cod. 10991)7, uno dei due canzonieri portoghesi che, nelle prime decadi del s. xvi, l’umanista Angelo Colocci fece copiare a Roma da un codice iberico di passaggio per la Curia pontificia.
Se il primitivo interesse per il codice era dovuto, effettivamente, alla bizzarra collocazione d’una cantiga – il cosiddetto «lai de Leonoreta» – attribuita proprio a Lobeira (ma con tutta evidenza un testo ‘spurio’ composto nelle prima decadi del ’300 alla corte di Alfonso XI di Castiglia), la complessa struttura del canzoniere colocciano e i molti segreti che intuiva nascosti nella conformazione di quell’apparentemente disordinata e incomprensibile silloge, portarono ben presto Anna Ferrari ad accantonare il primitivo progetto ecdotico e a dedicare tutti i suoi sforzi allo studio del Colocci-Brancuti. Il risultato di quelle ricerche quasi decennali, «Formazione e struttura del Canzoniere Portoghese della Biblioteca Nazionale di Lisbona», fu pubblicato nel 1979 negli Arquivos do Centro Cultural Português, allora diretti da José Vitorino da Pina Martins, e costituisce, ancora oggi, un punto di riferimento imprescindibile per gli specialisti. Nel rigoroso esame codicologico e paleografico dell’intero Canzoniere, la ricostruzione delle fasi di confezione del manoscritto si combina con l’analisi e l’interpretazione di elementi interni di primaria importanza per la soluzione di problemi, che incidono tanto sull’edizione dei testi come sul costituirsi dell’intera tradizione manoscritta. Nell’ampiezza dei dati e nell’acribia con cui sono raccolti e sistematizzati si manifestano in 221sommo grado le caratteristiche principali della Filologia coltivata da Anna Ferrari: la solidità del ragionamento filologico che poco o nulla lascia a speculazioni non sorrette da dati concreti e concretamente verificabili; l’attenzione minuziosa ai dettagli e la capacità di trascegliere quelli realmente funzionali alla soluzione dei problemi; lo stile inimitabile, rigoroso e geometrico, di cartesiana chiarezza.
L’importanza di «Formazione e struttura», non solo per la filologia galego-portoghese, ma in generale per l’intera tradizione degli studi romanzi, è testimoniata dalla nuova linfa che questo contributo ha saputo infondere alla cosiddetta «filologia dei canzonieri» – sviluppatasi non a caso nella scuola italiana e soprattutto nello studio delle sillogi provenzali –, come Aurelio Roncaglia ebbe a ribadire, in due ravvicinate occasioni, nella plenaria pronunciata ad apertura del convegno di Liegi del 1989 (Roncaglia, 1991, p. 37) e nella «Presentazione» (Roncaglia, 1990, p. vi) del fondamentale studio che Maria Careri (1990) ha dedicato al Canzoniere provenzale H. Nel contesto del rinnovato interesse della filologia materiale per i canzonieri – quella che, «con parafrasi non occulta», Anna Ferrari (2005, p. 26) amava denominare «philologie du regard» (Ferrari 2005, p. 26)8 –, la studiosa modenese fondò nel 1999 la collezione «Intavulare». Tavole di Canzonieri romanzi, pubblicata proprio a Modena (e non poteva essere altrimenti) dall’editore Mucchi, lo storico stampatore di Cultura Neolatina. Il progetto è articolata in quattro sezioni (canzonieri provenzali, canzonieri italiani, canzonieri portoghesi, sotto la direzione della stessa Anna Ferrari; canzonieri francesi, sotto la direzione di Madeleine Tyssens) e pubblica approfonditi studi codicologici sui canzonieri romanzi, corredati da un articolato sistema di indici. Fino ad oggi, sono apparsi 14 volumi della serie provenzale, 6 222volumi della serie francese e un volume della serie italiana, quasi tutti firmati da (all’epoca) giovani studiosi che, per le loro Tesi di Laurea o di Dottorato, avevano scelto di studiare questo o quel canzoniere, e che oggi sono (quasi tutti) affermati romanisti9. E questo, se da un lato conferma come lo studio sistematico delle testimonianze manoscritte sia fondamentale per irrobustire le competenze filologiche, dall’altro rivela l’attenzione e la generosa disponibilità che Anna Ferrari ha sempre avuto nei confronti delle ricerche di giovani studiosi.
L’interesse per la lirica galego-portoghese segnò anche l’inizio d’una profonda amicizia, umana e scientifica, con Elsa Gonçalves e (Alonso Montero, 2016, p. vi)
non é un episodio máis da súa biografía intelectual. A relación persoal entre estas dúas medievalistas prodúcese cando Elsa é lectora de Língua Portuguesa na Universidade de Roma, relación que axiña devén en amizade, que a profesión, lonxe de cuestionar, afondou e enriqueceu. Nobre exemplo o destas dúas romanistas que, en privado, se debruzan, ás veces, sobre as mesmas cuestións da lírica medieval, que, logo, unha delas publica nun Congreso ou nunha revista universitaria. Artigos hai, de Elsa, que se benefician das dilatadas conversas con Anna e vice-versa: dilatadas e, en moitas ocasións, divertidas conversas, como precisa a meticulosa Elsa Gonçalves cando lle dedica, á súa vella amiga, o artigo do ano 2013 “Sintaxe e interpretatio…”. Reza así a reveladora dedicatoria:
Para Anna Ferrari,
companheira no afã e no divertimento
da busca do rigor filológico.
Anna e Elsa. Elsa e Anna … tanto monta, monta tanto. È da questo sodalizio scientifico che sorge, già durante la preparazione di «Formazione e struttura», la coraggiosa (per quei tempi) contestazione dello stemma della lirica galego-portoghese disegnato da Tavani (due diversi antecedenti: 223uno per il Colocci-Brancuti; uno per il Canzoniere portoghese della Vaticana), contestazione (i due codici procedono da un solo antecedente, lo stesso per entrambi) che oggi è la conclusione (quasi) universalmente accettata, ma che nell’immediato suscitò non poche riserve e che fu anzi al centro d’un fervido e agguerrito dibattitto protrattosi fino a qualche decennio fa.
Quanto ad Anna Ferrari, il suo apporto alla discussione, oltre che allo studio del 1979, è affidato, da un lato, alle stimolanti sintesi (Ferrari, 1993a e Ferrari, 1993b) sui due canzonieri portoghesi B (il Colocci-Brancutri) e V (il Canzoniere della Biblioteca Vaticana), redatte per il Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa coordinato da Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani (1993)10, dall’altro agli splendidi contributi (splendidi fin dai titoli, un dono di cui la studiosa andava giustamente orgogliosa) apparsi tra il 1991a e il 2010: «Le chansonnier et son double»; «Sbagliando (loro) si impara (noi): tipologia e interesse dell’incipiens error nel Colocci-Brancuti»; «Perché non possiamo non dirci eterotopici ed eteronomici».
Il primo intervento (Ferrari, 1991a), una comunicazione letta al congresso di Liegi del 1989 su Lyrique Romane Médiévale: la tradition des chansonniers, sviluppa e approfondisce, a partire da una riflessione più ampia e panromanza sui «doppi» (non solo il caso, comunque istruttivo, dei codices descripti, ma anche quello dei manuscrits jumeaux), le anteriori conclusioni sui rapporti stemmatici tra B e V portoghesi e ribadisce, sulla base di solidi elementi codicologici (lacune incrociate) e paleografici (errori ottici incrociati), la dipendenza di entrambi i codici da un solo antecedente.
Il secondo intervento (Ferrari, 2001), presentato a un congresso padovano sui Canzonieri iberici, allestisce un catalogo ragionato della fenomenologia dell’incipiens error (ovvero l’errore rilevato e corretto currenti calamo dallo stesso copista) nell’operato delle sei mani che parteciparono alla confezione del canzoniere colocciano e, sulla base dell’incidenza di 224questo particolare tipo di errore in sede di divisione stichica, formula congetture sull’antecedente perduto, in cui i versi dovevano essere scritti uno di seguito all’altro, separati soltanto da punto metrico.
Il terzo contributo (Ferrari 2010) – anche in questo caso una comunicazione congressuale, al convegno compostelano su Estudos de edición crítica e lírica galego-portuguesa – risponde (fin dal titolo) all’accusa di «eterotopia» ed «eteronomia» che Tavani (2000 [2002], 21-27), aveva mosso allo stemma «D’Heur / Ferrari / Gonçalves», obiettando che la drastica potatura dei rami procede da presupposti extra-testuali (primo fra tutti il «disordine colocciano») che negherebbero validità ai risultati raggiunti. Anna Ferrari risponde punto per punto alle obiezioni mosse da Tavani, approntando così anche un sintetico ma efficace status quaestionis, e – ben cosciente della gravità della posizione metodologica assunta dal Maestro italiano – allarga il discorso a una più ampia riflessione sulla critica testuale:
Per quanto attiene alla “supervalutazione di presupposti extratestuali (la presunta disattenzione di Colocci […])” (Tavani 2002: 19, corsivo mio) – frase nella quale vorrei sostituire ‘elementi’ a “presupposti” ed eliminare “presunta”, in quanto, come detto, proverbiale e documentato è il disordine di Colocci così come la sua “disattenzione”, che io traduco automaticamente in ‘tendenza all’errore, indotta da elementi extratestuali (paratestuali, psicologici e quant’altro)’ –, imputata questa volta non a me ma al Resende de Oliveira (e in cui naturalmente percepisco il “dire a nuora perché suocera intenda”), mi suscita alcune riflessioni che prescindono dalla tradizione manoscritta della lirica galego-portoghese (Ferrari, 2010, p. 110-111; i corsivi sono dell’originale).
Segue, quindi, un’importante difesa della legittimità e della necessità di ricorrere, in sede ecdotica, all’extra-testualità:
Nella convinzione che la critica testuale (nel suo senso più allargato) abbia da sempre invocato in soccorso tutti i possibili strumenti extratestuali, sono sempre più persuasa che, data la nota difficoltà nell’individuazione degli errori, la salvezza del lachmannismo, al quale non possiamo abdicare, possa venire solo dall’esterno, con dei palliativi alla eccessiva rigidità del metodo, e proprio con il ricorso (s’intende, plausibile e ragionato) alle eterotopie/eteronomie negativamente evocate da Tavani (ibid., p. 111).
E la formulazione del principio metodologico è rafforzata da esempi pratici che ne confermano la validità. Alcuni sono casi di celebri correzioni 225congetturali (e non), entrati ormai nella storia della disciplina e come tali menzionati anche nei manuali universitari; altri, invece, sono exempla ficta, elaborati ad hoc dalla studiosa, che meritano però di essere citati anche per la capacità (concessa davvero a pochi) che Anna Ferrari aveva di formulare rigorose e serissime riflessioni (in questo caso sulla critica testuale) con accenti leggeri, informati da scintillante ironia. Il primo esempio chiama in causa l’alterità numismatica:
una banalissima frase quale “spendevo trecento, mi ha dato di resto cento” non potrà essere accolta a testo se i conti non tornano, vale a dire se non ho preventivamente appurato che esistevano tagli (monete o banconote) da 200 o da 400: se non esistevano, dopo aver sconfinato per la verifica nell’alterità numismatica devo necessariamente modificare almeno una delle cifre e espormi all’accusa di etero- (ibid., p. 111).
Il secondo esempio, invece, sconfina nell’alterità calcistica e non sorprenderà affatto chi conosceva bene Anna Ferrari romanista (per settore di studi) «romanista» (per fede sportiva):
se in una cronaca sportiva leggo che sull’uno a uno con l’Inter “la Roma ha rischiato di fare un altro gol” […] modifico immediatamente il fare in subire, invocando un banale errore polare (enantiosemia); ma sbaglio, perché […] potrei scoprire che il giornalista sportivo è dell’Inter e che quindi l’errore non si cela nel verbo fare, bensì nel ha rischiato = ‘è stata sul punto di’[…]: altrettanto banale l’errore, ma assai diversa e non meno dannosa la causa, in questo caso di natura altrimenti psicologica e riconducibile a forte passione interista, e in ogni caso assai diversa la necessaria correzione congetturale […]. E mi si perdoni la callida iunctura, non certo tra lirica galego-portoghese e calcio, bensì tra Roma e Inter …! (ibid., p. 111; i corsivi sono dell’originale).
Animata da una vivace e instancabile curiosità, Anna Ferrari era di carattere franco e aperto. Alla spontaneità del tratto, all’eleganza seducente dei modi e alla schiettezza delle opinioni, si accompagnavano un’energica vitalità e un’indole rigorosa e caparbia (aggettivo da lei molto amato e di cui esaltava la valenza positiva), che la portava ad esigere sempre il massimo, soprattutto da se stessa. Si poteva rimanere sconcertati – e io stesso lo fui quando vent’anni fa mi ritrovai ad assistere alle sue lezioni – di fronte, da un lato, alla generosa disponibilità nei confronti di colleghi e scolari, e dall’altro a una durezza di carattere, sempre sorretta da intenti pedagogici, che non lasciava il minimo spazio all’indulgenza e che si traduceva, anzi, in una brutale indifferenza verso 226ciò che, secondo lei, non meritava alcuna attenzione, in quanto del tutto inutile per il progresso delle ricerche: resteranno proverbiali, tra chi l’ha frequentata, gli arroventati strali scagliati contro i «cincischiamenti» di quanti spaccia(va)no per assolute novità le banali (quando non mediocri) rivisitazioni di quanto già detto, in passato, dai Maestri.
Ma ad Anna non sarebbe piaciuto che il suo profilo approdasse, nelle battute finali, all’aneddotica soggettiva. Era convinta che, quanto ai rapporti personali, ognuno ha il diritto di avere la propria idea e che l’episodicità aneddotica e le annotazioni di carattere privato sia meglio lasciarle agli incontri conviviali e al formato informale delle consuete «quattro chiacchiere tra amici». Concludo allora questo profilo con tre rapide annotazioni marginali che, senza allontanarsi troppo dal versante scientifico, compendieranno però alcuni ricordi personali.
La prima nota è una citazione e viene dall’Art poétique di Nicolas Boileau (1636-1711). Anna non amava molto il severo Régent du Parnasse (non posso ripetere in questa sede l’epiteto che era solita riservargli), ma tutti i suoi studenti hanno perso il conto delle volte in cui si sono sentiti rimproverare con il v. 153 del primo canto: «Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement» (ed. Bénac, 1946). Il monito per noi «apprendisti stregoni» era, ovviamente (e lei stessa lo aveva sempre messo in pratica), che non si può scrivere un solo rigo senza prima aver pensato molto, in quanto i problemi di un testo scritto male derivano, a monte, dal fatto che il testo è stato pensato male. La paternale – o «maternale», come ad Anna piaceva dire, ma il dibattito non è mai approdato a un punto fermo – terminava poi con i tre versi che precedevano la prima citazione (Boileau, I, v. 150-152; ed. Bénac, 1946):
Avant donc d ’ écrire apprenez à penser:
selon que notre idée est plus ou moins obscure,
l ’ expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
E i versi di Boileau servivano anche per ribadire un’idea della Filologia come disciplina essenzialmente artigianale, nel senso più alto e più nobile del termine. I filologi, amava dire, sono como i muratori: si sporcano le mani (e non solo, letteralmente, per la polvere di biblioteche e archivi) e faticano di più per (ri)costruire il testo; poi arrivano gli architetti (i critici letterari) e lo trovano già pronto per le loro raffinate riflessioni (quest’ultima frase con l’ironia tagliente di cui lei sola era capace).
227La seconda nota è un sillogismo e suona più o meno così:
— non si può studiare la lirica galego-portoghese senza conoscere la lirica provenzale;
— in Portogallo non ci sono biblioteche dotate degli strumenti necessari per studiare la lirica provenzale;
ergo
— non si può studiare la lirica galego-portoghese in Portogallo.
Me lo sono sentito ripetere tante volte, sia da studente (quando di lirica galego-portoghese non volevo neppure sentir parlare), sia dopo, quando ho cominciato a occuparmene con una certa sistematicità, e proprio a Lisbona. Di là dallo spiritoso paradosso, così tipico del carattere di Anna Ferrari, il sillogismo ribadisce però la necessità di studiare la prima lirica in volgare iberico, non come fenomeno isolato, ma contestualizzandola entro il più ampio panorama romanzo, perché è solo così che se ne possono additare i caratteri specifici e le differenze peculiari. Penso, a tal riguardo, al contributo sui «Linguaggi lirici in contatto», dove la portata dell’influsso provenzale sui poeti della prima scuola iberica è messa a fuoco attraverso la spigolatura di elementi significativi, rintracciati per lo più nei «canzonieri» dei Re-trovatori (Alfonso X e suo nipote D. Denis), che dimostrano come l’imitazione passi, da un lato, più che per le coincidenze tematiche e lessicali, per le riprese tecnico-formali e, dall’altro e soprattutto, attraverso la lettura di Canzonieri antichi (Ferrari, 1984 [2014b]). Ma viene in mente anche il saggio su «Marcabru, Pedr’Amigo de Sevilha e la pastorella galego-portoghese», che dimostra come il trovatore iberico ha imitato la pastorella marcabruniana a partire da un modello scritto, conclusione che incide sulla complessa questione della circolazione di canzonieri provenzali nella Península (Ferrari, 1999a [2014b]).
La terza e ultima nota è un leixa-pren, sul modello dei trovatori galego-portoghesi. E non stupirà che la «fine esegeta di virtuosissimi componimenti trobadorici» (Gonçalves, 2014, p. 20) abbia voluto affidare a questo particolare artificio il suo personale compendio di vita e di mestiere scientifico:
non dobbiamo dire tutto ciò che pensiamo
non dobbiamo scrivere tutto ciò che diciamo
non dobbiamo pubblicare tutto ciò che scriviamo.
228E a questo, poco si può aggiungere. Anche in questo caso, le agudezas del ragionamento fissano nella movenza di un ulteriore apparente paradosso l’esigenza d’una scrittura preceduta da ampi studi, alimentata da lunghi periodi di riflessione e sostenuta da un intenso labor limae.Da qui, dalla consapevolezza che vale la pena pubblicare solo quando si ha qualcosa di veramente nuovo da dire, oltre che dal desiderio che quanto si è pubblicato resista il più possibile al passare del tempo – e quasi nessuno dei suoi contributi può dirsi davvero superato –, nasce il rapporto peculiare (per certi versi, si potrebbe dire anche conflittuale) di Anna Ferrari con il momento cruciale, nella vita d’uno studioso, che è la pubblicazione dei risultati delle proprie ricerche: alla quantità, ha sempre preferito la qualità, dei contenuti e della forma. E quando non era possibile raggiungerla, ha preferito non stampare nulla.
Mi tornano alla memoria alcuni versi di Eugénio de Andrade e sono sicuro che ad Anna non sarebbe dispiaciuto di vederli citati a conclusione d’un suo ricordo:
Sê paciente; espera que a palavra amadureça
e se desprenda como um fruto ao passar
o vento que a mereça.
[Sii paziente; aspetta che la parola maturi / e si lasci cadere come un frutto al passaggio / del vento che la meriti]
Fabio Barberini
Universitat de Girona
229RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Alonso Montero, Xesús, 2016. «Limiar. Da Filoloxía galega e da Filoloxía portuguesa (arredor de 1980) na biografía intelectual de Elsa Gonçalves», in Gonçalves, Elsa. De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses, ed. J. Dionísio / M. A. Ramos / H. Monteagudo, La Coruña, Real Academia Galega, p. v-xx.
Asperti, Stefano, 2017. «Roncaglia, Aurelio». Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 17, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, [cito dalla versione elettronica <https://www.treccani.it/enciclopedia/aurelio-roncaglia_%28Dizionario-Biografico%29/> (data di consultazione: 14/09/2023).
Bénac, Henri (éd.), 1946. Nicolas Boileau,Art poétique, Parigi, Hachette.
Bertolucci Pizzorusso, Valeria, 1963. Le poesie di Martin Soares, Bologna, Libreria antiquaria Palmaverde.
Billy, Dominique, 1989. L’architecture lyrique médiévale: analyse métrique et modélisation des structures interstrophiques dans la poésie lyrique des troubadours et des trouvères, Montpellier, Section française de l’Association Internationale d’Études Occitanes.
Careri, Maria, 1990. Il Canzoniere provenzale H. Struttura, contenuto e fonti, Modena, Mucchi.
Cunha, Celso Ferreira da (ed.), 1945. O Cancioneiro de Paai Gômez Charinho, Rio de Janeiro, Facultade Nacional da Universidade do Brasil.
Cunha, Celso Ferreira da (ed.), 1949. O Cancioneiro de Joan Zorro, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.
Cunha, Celso Ferreira da (ed.), 1956. O Cancioneiro de Martin Codax, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.
Ferrari, Anna, 1971. «Bernart de Ventadorn ‘fonte’ di Peire Vidal?», Cultura Neolatina 31, p. 171-203.
Ferrari, Anna, 1979. «Formazione e struttura del Canzoniere Portoghese della Biblioteca Nazionale di Lisbona (Cod. 10991: Colocci-Brancuti): premesse codicologiche alla critica del testo (materiali e note problematiche)», Arquivos do Centro Cultural Português 14, p. 27-142.
Ferrari, Anna, 1984. «Linguaggi lirici in contatto: trobadors e trobadores», Boletim de Filologia 29, p. 35-58 (= Homenagem a Manuel Rodrigues Lapa, vol. II) [riedito in Ferrari, 2014b, p. 31-60].
Ferrari, Anna, 1990 [2022]. «Conversa con Elsa Gonçalves e Anna Ferrari en Compostela» (intervista raccolta da Henrique Monteagudo), Grial 108, p. 477-490 [riedito nell’omaggio collettivo a Elsa Gonçalves, coordinato 230da A. Ferrari, «Parliamo di Elsa», Cultura Neolatina 82, 2022, p. 155-218; l’intervista con minimi tagli e correzione dei refusi dell’originale, si legge alle p. 186-195].
Ferrari, Anna, 1991a. «Le chansonnier et son double», Lyrique romane médiévale: la tradition des chansonniers, Actes du colloque de Liège, 1989, éd. par M. Tyssens, Liegi, Publications de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Lièges, p. 330-337.
Ferrari, Anna, 1991b. «Rima derivativa e critica testuale: Grimoart Gausmar, Lanquan lo temps renovelha (BdT 190,1)», Cultura Neolatina 51, p. 121-206.
Ferrari, Anna, 1992. «Peire Vidal ou ‘de la perfection’», Contacts de langues, de civilisations et intertextualité, Actes du IIIe Congrès international de l’Association Internationale d’Études Occitanes(Montpellier, 20-26 septembre 1990), éd. G. Gouiran, 3 vol., Montpellier, Centre d’études occitanes de l’Université de Montpellier, vol. 3, p. 879-891.
Ferrari, Anna, 1993a. «Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Colocci-Brancuti)», in Lanciani/Tavani, 1993, p. 119-123.
Ferrari, Anna, 1993b. «Cancioneiro da Biblioteca Vaticana», in Lanciani/Tavani, 1993, p. 123-126.
Ferrari, Anna, 1993c. «Parola-rima», O cantar dos trovadores. Actas do Congreso celebrado en Santiago de Compostela entre os días 26 e 29 de abril de 1993, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, p. 121-136 [riedito in Ferrari, 2014b, p. 61-84].
Ferrari, Anna, 1999a. «Marcabru, Pedr’Amigo de Sevilha e la pastorella galego-portoghese», Romanica Vulgaria – Quaderni (= Studi provenzali 98-99) 16-17, p. 107-130 [riedito in Ferrari, 2014b, p. 85-106].
Ferrari, Anna, 1999b. «Premessa», Filologia classica e Filologia romanza: esperienze ecdotiche a confronto, Atti del Congresso internazionale (Roma 25-27 maggio 1995), a c. di A. Ferrari, Spoleto, CISAM, p. xi-xv.
Ferrari, Anna, 2001. «Sbagliando (loro) s’impara (noi): tipologia e interesse dell’incipiens error” nel Colocci-Brancuti». Canzonieri iberici, Atti del Colloquio di Padova e Venezia, 25-27 maggio 2001, a c. di P. Botta / C. Parrilla / I. Pérez Pascual, 2 vols., Noia (La Coruña), Toxosoutos, vol. 1, p. 107-123.
Ferrari, Anna, 2005. «La Copilaçam gilvicentina: uno strano Canzoniere», Filologia dei testi a stampa (area iberica), a c. di P. Botta, Modena, Mucchi, p. 25-45.
Ferrari Anna, 2010. «Perché non possiamo non dirci eterotopici ed eteronomici», Estudos de edición crítica e lírica galego-portuguesa, ed. M. Arbor Aldea / A. Fernández Guiadanes, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, p. 103-114.
Ferrari, Anna, 2012. «Da strofe di canzone provenzale a sonetto italiano: Polo Zoppo e Perdigon», Cultura Neolatina 72, p. 251-263.
231Ferrari, Anna, 2014a. «Dittico per Claudio: 1. Altre due foglie (e un ramo); 2. Adamastor», Fondocampo, per Claudio Colaiacomo, a c. di A. Abruzzese, Roma, Luca Sossella editore, p. 85-95.
Ferrari, Anna, 2014b. Trobadors e trobadores, a cura di F. Barberini, prologo di E. Gonçalves. Modena, Mucchi [riedizione in volume di Ferrari, 1984; Ferrari, 1993 e Ferrari, 1999a].
Ferrari, Anna, 2017. «Bernart de Ventadorn ou l’apogée de la courtoisie», Bernard de Ventadour: Folle amour et courtoisie, Carrefour Ventadour, Moustier Ventadour, p. 77-92.
Ferrari, Anna, 2019. «Ernesto Monaci e la lirica galego-portoghese», Studj Romanzi 15, p. 79-96 [= Atti del Congresso Ernesto Monaci 1918-2018. La fondazione della Filologia romanzae della Paleografia in Italia, Roma, dicembre 2018].
Gonçalves, Elsa (ed.), 1999. Cunha Celso Ferreira da, Cancioneiros dos Trovadores do Mar, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Gonçalves, Elsa, 2013. «Sintaxe e interpretatio: Alfonso X, Joan Rodriguiz foi esmar a Balteira (B 481/V 64)», Cultura Neolatina 73, p. 13-24 [riedito in Gonçalves, Elsa, 2016. De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses, ed. J. Dionísio / M. A. Ramos / H. Monteagudo, La Coruña, Real Academia Galega, p. 555-565].
Gonçalves, Elsa, 2014. «Prologo» a Ferrari, 2014b, p. 19-27.
Guiette, Robert, 1972. D’une poésie formelle en France au Moyen Âge, Paris, Nizet.
Lanciani, Giulia / Tavani, Giuseppe (coord.), 1993. Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuiguesa, Lisbona, Caminho.
Lang, Henry Roseman, 1894. Das Liederbuch des Königs Denis von Portugal. Zum ersten Mal vollständig herausgegeben und mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar versehen, Halle a. S., Max Niemeyer Verlag [oggi accessibile in traduzione portoghese: Lang, Henry Roseman, 2010. Cancioneiro d’el Rei Dom Denis e Estudos Dispersos, Edição organizada por L. M. Mongelli / Y. Frateschi Vieira, Niterói (Rio de Janeiro), EdUFF].
Michaëlis de Vasconcellos, Carolina, 1904. Cancioneiro da Ajuda. Edição crítica comentada, 2 vols., Halle a. S., Max Nimeyer Verlag.
Nobiling, Oskar, 1908. «As cantigas de D. Johan Garcia de Guilhade trovador do seculo. xiii», Romanische Forschungen 25, p. 641-719 [riedito in Nobiling, Oskar, 2007. As cantigas de D. Joan Garcia de Guilhade e Estudos Dispersos, org., intr. e notas de Y. Frateschi Vieira, Niterói (Rio de Janeiro), EdUFF].
Nunes, José Joaquim, 1926-1928. Cantigas d’amigo dos trovadores galego-portugueses. Edição crítica acompanhada de introdução, variantes e glossário, 3 vols., Coimbra, Imprensa da Universidade.
232Nunes, José Joaquim, 1932. Cantigas d’amor dos trovadores galego-portugueses. Edição crítica acompanhada de introdução, comentário, variantes e glossário, Coimbra, Imprensa da Universidade.
Riquer, Martín de, 1975. Los Trovadores. Historia literaria y textos, 3 vols., Barcellona, Ariel.
Roncaglia, Aurelio, 1958. «Carestia», Cultura Neolatina 18, p. 121-137.
Roncaglia, Aurelio, 1968. La generazione trobadorica del 1170 (testi e appunti del corso di Filologia romanza […] per l’anno accademico 1967-1968), Roma, Libreria De Santis.
Roncaglia, Aurelio, 1990. «Presentazione», in Careri, 1990, p. v-vii.
Roncaglia, Aurelio, 1991. «Rétrospectives et perspectives dans l’étude des chansonniers d’oc», Lyrique romane médiévale: la tradition des chansonniers, Actes du colloque de Liège, 1989, éd. par M. Tyssens, Liegi, Publications de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Lièges, p. 19-38 (+ 38-41, discussione).
Stegagno Picchio, Luciana, 1969. Martin Moya. Le poesie, Roma, Edizioni dell’Ateneo.
Stimming, Albert, 1886. Der Troubadour Jaufre Rudel, sein Leben und seine Werke, Berlino, A. Hettler.
Tavani, Giuseppe, 1964a. Le poesie di Ayras Nunez, Milano, Ugo Merendi editore.
Tavani, Giuseppe, 1964b. Lourenço. Poesie e tenzoni, Modena, Mucchi.
Tavani, Giuseppe, 1969. «La tradizione manoscritta», Id., Poesia del Duecento nella Penisola Iberica. Problemi della Lirica galego-portoghese, Roma, Edizioni dell’Ateneo, p. 79-179.
Tavani, Giuseppe, 2000 [2002]. «Eterotopie ed eteronomie nella lettura dei canzonieri galego-portoghesi», Estudis romànics 22, p. 139-153 [riedito in Tavani, Giuseppe, 2022. Tra Galizia e Provenza. Saggi sulla poesia medievale galego-portoghese, Roma, Carocci, p. 13-28].
1 Al maschile, sì, come lei stessa esigeva che fosse indicata la sua qualifica accademica, rivendicando d’essere un «professore donna» e lodando la grande civiltà della lingua francese che, per l’appunto, diceva Madame le Professeur.
2 Per i lettori più giovani di Cultura Neolatina, lo Schedario è stata una sezione della rivista che, tra gli anni ’70 e ’80 (in tempi ben lontani delle banche dati digitali), offriva informazione bibliografica: redattori e collaboratori della rivista redigevano schede di breve estensione, relative ad articoli e volumi di recente pubblicazione, che presentavano un riassunto del testo schedato e una succinta valutazione critica. Le schede redatte da Anna Ferrari abbracciano ampi settori della romanistica con particolare attenzione a quelli che sono stati i suoi campi privilegiati di studio: l’amato Bernart de Ventadorn; le strutture metriche gli artifici retorici della lirica provenzale; la poesia d’oc in terra iberica; il romanzo medioevale francese e occitano; la filologia degli umanisti italiani. Si segnala, inoltre, che un certo numero di schede è dedicato a titoli relativi al franco-provenzale.
3 «Provenzali», e non «occitani», come oggi s’usa, ma come ad Anna Ferrari non piaceva. A quanti, incautamente, tentavano di correggerla, era pronta a ricordare che Dante parla di «Provinciales»; che il tolosano Peire Vidal celebrava il ritorno in patria con gli splendidi versi «Ab l’alen tir vas me l’aire / qu’eu sen venir de Proensa» (che, non a caso, Pasolini sceglierà come epigrafe d’una sua raccolta di versi in friulano) e che D. Denis, re del Portogallo e «immenso trovatore», componeva «em maneira de proençal», in quanto «Proençaes soen mui bem trobar / e dizem eles que é com amor».
4 Ancor più (provocatoriamente) drastico è il giudizio espresso in Ferrari, 2014a (p. 85, nota 4): «Non posso non ripetere il mio ‘pensiero dominante’, vale a dire che è proprio questo rendere fisse (nella sestina, una pessima invenzione arnaldiana) le strabilianti acrobazie metriche dei trovatori precedenti che – non disgiuntamente dal declino dell’ideologia, che con Bernart de Ventadorn aveva raggiunto il suo acme e non poteva quindi che subire una battuta d’arresto per poi decrescere – ammazza la poesia provenzale dall’interno (quindi ‘morte naturale’, seppur certo con il sostanziale aiuto della crozada antialbigese)».
5 Come ricorda Ferrari (2012, p. 251 nota *), «In quell’occasione, la mia comunicazione sostituì quella prevista di Saverio Guida, poi impossibilitato a partecipare al penultimo momento, e fu spiritosamente presentata dal Presidente della sessione, Andrea Fassò, con le parole “La Ferrari al posto di Guida!”». A motivare la ripresa del vecchio intervento non pubblicato fu la stampa, in quello stesso fascicolo di Cultura Neolatina (il vol. 72 del 2012), d’un contributo di J. Matasci dedicato al sonetto di Polo Zoppo e al suo modello provenzale. Si componeva così un dittico in cui due studiose di generazioni diverse si confrontavano sullo stesso argomento e Anna Ferrari commentò l’‘esperimento’ in questi termini: «Mi decido a stampare, quasi vingt ans après, in quanto trovo l’accostamento estremamente interessante a documentare, intanto, che lo stesso problema può essere recepito da diversi punti di vista, come in questo caso dimostra la stessa scelta dei titoli […], a documentare, inoltre e soprattutto, i reali (oggettivi) progressi della nostra disciplina, come dimostra il taglio più aperto, di più ampio respiro – e tuttavia tecnico e rigoroso − dell’articolo di J. M. […]. Numerosi sono i punti di accordo tra i due lavori, ma più interessanti sono i rari punti di disaccordo: infatti, le alcune non-coincidenze, ovvero diverse sfumature di interpretazione e di punto di vista, saranno certo stimolo alla riflessione per le due autrici e con loro, mi auguro, anche per tutti i lettori» (ibid., p. 251).
6 Dopo le pionieristiche edizioni di D. Denis e di Johan Garcia de Guilhade, rispettivamente Lang (1894) e Nobiling (1908), entrambe di scuola tedesca, risultati di elevata qualità erano arrivati soltanto dal Brasile di Celso Cunha che, tra la fine degli anni ’40 e la prima metà della decade successiva, pubblica i corpora di Pai Gomez Charinho, Johan Zorro e Martin Codax (rispettivamente Cunha, 1945; 1949 e 1956; oggi riediti in un solo volume cf. Gonçalves, 1999). In Italia, una delle prime edizioni monografiche galego-portoghesi, se non la prima in assoluto, si deve a Valeria Bertolucci Pizzorusso (1963; Martin Soares), seguita l’anno dopo da Tavani (1964a e 1964b; Airas Nunez e Lourenço) e da Luciana Stegagno Picchio (1969; Martin Moya).
7 È la stessa Anna Ferrari a descrivere, in termini fortemente emotivi, il suo primo incontro con il Canzoniere colocciano: «O traballo que eu tiña decidido facer era sobre Johan Lobeira. Traballei neste autor, pero máis interesante foi o contacto con Pina Martins e Cintra, e sobre todo o coñecemento do Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Eu pasaba todo o día metida na Biblioteca a estudar o Cancioneiro, porque no entanto contraera unha intensa paixón por el, foi un verdadeiro ‘coup de foudre’, un frechazo. Así que o vin, comecei a chorar» (Ferrari, 1990 [2022], p. 189). L’episodio è immortalato, a mo’ di omaggio personale, in una poesia di Xesús Alonso Montero che si intitola As bágoas da Anna.
8 La compiuta formulazione del concetto, da intendere come equivalente di «filologia materiale», risale ad anni (relativamente) recenti (Ferrari, 2005, p. 26 e Ferrari, 2019, p. 90). La riflessione su questo tema rimonta però alla prima metà degli anni ’90 e se ne rinviene traccia scritta nella «Premessa» agli atti del Convegno romano del 1995 su Filologia classica e Filologia romanza, organizzato dalla stessa Anna Ferrari: «come non sfuggirà ai lettori più attenti, l’indice del volume non coincide appieno con il programma del Convegno. Rispetto a questo, infatti, mancano due contributi: quello di Cesare Questa […] e il mio, che avrei intitolato, in modo un po’ oltranzista, “La philologie du regard” (non senza riferimento all’“École du regard”), un tipo di approccio applicabile forse solo a ‘libri’ strutturati, quali i Canzonieri della lirica romanza ed affini» (Ferrari, 1999b, p. xiii-xiv).
9 Quanto alla serie provenzale sono stati pubblicati, dal 1999 ad oggi, i volumi dedicati ai seguenti canzonieri (per ordine di pubblicazione): AFLOH (A. Ferrari, M. Careri, A. Lombardi); IK (W. Meliga); V (I. Zamuner); P (G. Noto); S (L. Borghi Cedrini); G (F. Carapezza); C (A. Radaelli); J (E. Zimei); B (S. Romualdi); Sg (S. Ventura); VeAg (A. Alberni); f (F. Barberini); a, aII, a1 (W. Meliga / L. Borghi Cedrini). Negli ultimi anni, Anna Ferrari e Elsa Gonçalves, con la collaborazione di Fabio Barberini, stavano preparando il primo volume della serie portoghese di «Intavulare», dedicato al Canzoniere Colocci-Brancuti. La recente scomparsa di Elsa Gonçalves (febbraio 2022) e, adesso, quella di Anna Ferrari hanno impedito la conclusione del lavoro. Ma è auspicabile che tale preziosa eredità non vada perduta.
10 Per Lanciani/Tavani (1993), Anna Ferrari redige anche le voci «Johan Lobeira»; «Lai» e «Palavra-rima». A questi interventi, esemplari per l’equilibrio tra sintesi e ricchezza degli spunti di riflessione, sono da aggiungere le voci redatte, nel 1995, per la Biblos. Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua Portuguesa: «Juião Bolseyro»; «Cancioneiro da Biblioteca Vaticana»; «Cantiga de amor» e «Cantiga de escarnho e maldizer». Per i riferimenti bibliografici completi rinvio alla Bibliografia degli scritti di Anna Ferrari, in appendice a questo ricordo.