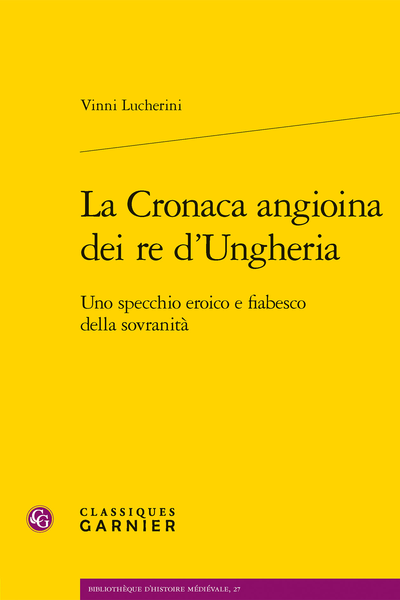
Prefazione I gradi di fruizione di un manoscritto miniato regale
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : La Cronaca angioina dei re d’Ungheria. Uno specchio eroico e fiabesco della sovranità
- Pages : 7 à 17
- Collection : Bibliothèque d'histoire médiévale, n° 27
- Thème CLIL : 3386 -- HISTOIRE -- Moyen Age
- EAN : 9782406113836
- ISBN : 978-2-406-11383-6
- ISSN : 2264-4261
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11383-6.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 30/06/2021
- Langue : Italien
Prefazione
I gradi di fruizione di un manoscritto miniato regale
Il Cod. Lat. 404 della Országos Széchényi Könyvtár di Budapest è un prezioso manoscritto miniato confezionato intorno al 1358 nel Regnum Hungariæ, un regno che nel Medioevo si estendeva su un’ampia area dell’Europa centro-orientale compresa tra i Carpazi e l’Adriatico1. Il codice, già noto come Chronicon pictum Vindobonense, Wiener Bilderchronik o Bécsi Képes Krónika per esser stato custodito circa tre secoli a Vienna2, è il testimone più antico di una cronaca che, prendendo l’avvio dal racconto biblico e passando per la fondazione della monarchia ungherese da parte di santo Stefano, si concludeva con le vicende del re Carlo I (1310-1342), giunto in Ungheria da Napoli (dove era chiamato Caroberto)3, primogenito del principe Carlo Martello4, a sua volta primogenito del re di Sicilia Carlo II d’Angiò (1289-1309)5 e della regina Maria6, figlia del re d’Ungheria Stefano V (1270-1272)7.
Nel bas-de-page della pagina d’incipit si dispiega una fascia nella quale sono affiancati cinque piccoli quadrati, tre dei quali contengono blasoni araldici inseriti in altrettanti compassi polilobati profilati di azzurro su sfondi a foglia d’oro. Nel primo compasso vi è uno scudo partito, nel 1º fasciato di rosso e d’argento di otto pezzi, cioè lo stemma detto d’Ungheria antico, documentato per la prima volta sul verso del sigillo d’oro del re Emerico (1196-1204) e probabilmente già usato dal re Bela III (1172-1196); nel 2º d’azzurro seminato di fiordalisi d’oro, cioè il semis de fleurs-de-lys capetingio abitualmente impiegato in Ungheria in riferimento all’origine angioina del re Carlo I8. Nel secondo compasso campeggia il blasone dei re d’Ungheria, di rosso, alla croce patriarcale e patente d’argento movente da un monte di tre cime di verde, il cui primo uso araldico si deve al re Bela IV (1235-1270)9. Nel terzo compasso si staglia il cimiero con lo struzzo d’argento sorgente da una corona e tenente nel becco un ferro di cavallo d’oro10, la divisa propria dei due sovrani che governarono l’Ungheria per quasi tutto 8il Trecento: il già ricordato Carlo I e suo figlio Ludovico (1342-1382), detto il Grande11.
Nato il 5 marzo 1326 a Wyssegrad12, consacrato re d’Ungheria il 21 luglio 1342 e re di Polonia il 17 novembre 137013, Ludovico è raffigurato due volte sulla pagina d’incipit: la prima, in maestà14, al centro di una grande miniatura di formato rettangolare, affiancato da due gruppi di uomini armati connotati socialmente ed etnicamente; la seconda, inginocchiato con sua moglie Elisabetta di Bosnia in atteggiamento orante verso santa Caterina, all’interno dell’iniziale A che introduce un passo rubricato: Anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, feria tertia infra octavas ascensionis eiusdem Domini, incepta est ista cronica de gestis Hungarorum, antiquis et novissimis, ortu et progressu, victoria eorundem et audacia, collecta ex diversis cronicis veteribus, earundem veritates ascribendo et falsitatem omnino refutando. In nomine Domini amen. Incipit prologus in Cronicam Hungarorum15. La cronaca delle gesta antiche e recentissime degli ungheresi, della loro origine e del loro sviluppo, della loro vittoria e della loro audacia, fu dunque iniziata il 15 maggio 135816, collazionando materiali tratti da diverse vecchie cronache, delle quali si erano accolte le verità e si era epurata ogni falsità17. Qualche giorno dopo, il 27 maggio, Ludovico incontrò a Visegrád un’ambasceria della città di Ragusa, a cui garantì protezione e autonomia, a pochi mesi dal Trattato di Zara (18 febbraio 1358) che aveva assicurato all’Ungheria il pieno controllo sulle terre dalmate18, privando i dogi di Venezia del titolo di dux Dalmatiæ et Croatiæ: un periodo cruciale nella storia del regno19, contrassegnato dal superamento in chiave adriatica dell’insuccesso delle campagne napoletane seguite all’assassinio di Andrea, fratello minore di Ludovico e marito di Giovanna d’Angiò, avvenuto ad Aversa nel 134520.
Il re che sormonta la prima pagina del manoscritto esercitava una funzione ben più forte di una dichiarazione di proprietà21. Il suo corpo, vestito delle insegne araldiche22, legittimava implicitamente la veridicità di quanto nel codice era scritto e nondimeno raffigurato23. Nell’affermare le radici napoletane della dinastia, espresse non solo per mezzo dell’araldica, ma attraverso una genealogia per immagini intese come forme del continuum storico24, il Chronicon pictum rivendicava, infatti, l’origine antica della beata stirps ungherese25, della quale il sovrano regnante e suo padre si erano considerati parte integrante: il passato si rifletteva in tal modo nel presente e persino nel futuro dell’Ungheria26. La cronaca e le 9miniature creavano (e creano tuttora) l’impressione di un’ininterrotta sequenza temporale, nella quale i re di origine angioina potevano dirsi ungheresi ed esser riconosciuti come tali, senza rinunciare alla parte napoletana della propria identità. L’intero manoscritto veicolava, pertanto, un messaggio politico27, configurandosi come un prodotto esemplare della duplice esigenza, che era stata di Carlo I e che Ludovico condivise, di appropriarsi della cultura ungherese e di conciliarla con quella angioina, di per sé transculturale, per servirsene nelle procedure comunicative che entrambi misero in atto.
Il primo elemento che fin dall’anno Mille aveva reso beata la dinastia regnante era la triade dei cosiddetti sancti reges28, costituita dal re Stefano, nato nel 969 secondo il cronista, verosimilmente intorno al 980-98129, morto il 15 agosto 1038 e canonizzato nel 108330; da suo figlio, il principe Emerico (1007-1031), pure canonizzato nel 1083, ma mai incoronato31; e dal re Ladislao (ca. 1040-1095), canonizzato nel 1192, al tempo di Bela III32. Il secondo elemento coincideva con la sacralità dell’istituzione monarchica33, identificata per sineddoche con una sacra corona che si riteneva inviata a Stefano da un papa romano, ora custodita nel Palazzo del Parlamento di Budapest34. Il terzo elemento, introdotto da Carlo I, derivava dalla santità dinastica napoletana, incarnata in Ludovico d’Angiò (1274-1297)35, vescovo di Tolosa, canonizzato nel 1317, il cui nome, già derivante da quello dell’omonimo re-santo di Francia, era stato assegnato proprio da Carlo I a suo figlio. Malgrado che i re-santi ungheresi siano sempre effigiati nel Cod. Lat. 404 come guerrieri eroici o protagonisti di storie fiabesche, e sebbene le miniature non alludano mai alla materialità della sacra corona, il manoscritto rendeva palese che Ludovico, attraverso suo padre, era discendente non solo dei sovrani e dei santi d’Ungheria, ma anche dei sovrani di Napoli e dei loro santi, e che esercitava il suo ministero ispirato da Dio come un sacerdote, la sua giustizia e la sua sapienza impedendo al regno di cadere nella tirannide, secondo quanto leggiamo nel prologo, che non è il prologo di una cronaca della gesta di un popolo, ma che è appunto il prologo delle gesta dei re ungheresi.
Quando ci interroghiamo sugli esempi di manoscritti miniati con cui confrontare il Chronicon pictum, non troviamo comparazioni utili con le narrazioni parziali di eventi storici riguardanti un sovrano europeo, come il Codex Balduini Trevirensis (Landeshauptarchiv Koblenz, i C, 1)36, 10né con i racconti epici o mitici, come le storie sulla distruzione di Troia37, né con le cronache universali38, perché si tratta di testi che potevano sì essere illustrati nei medesimi atelier39, con l’ausilio di analoghe strategie figurative, in un contesto di frequenti scambi iconografici tra un genere e l’altro, ma che rispondevano a premesse e funzioni molto diverse da quelle di una cronaca nazionale illustrata. I confronti andrebbero ricercati, infatti, in quelle operazioni che nascevano dall’ambizione di ricostruire e rappresentare in maniera integrale la storia di un regno40, come l’Historia regum Anglorum41 o le Grandes Chroniques de France42. Queste ultime, tramandate attraverso più di cento manoscritti dei quali 75 miniati con cicli da una fino a 400 miniature, comprendevano una parte corrispondente al Roman des roys, cioè una sequenza di biografie dei christianissimi reges compilata dal monaco Primate di Saint-Denis e offerta a Filippo III le Hardi (1270-1285) verso il 1275, in un esemplare decorato con 36 riquadri e iniziali istoriate (Parigi, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 782); e un’altra parte formatasi con aggiunte progressive fino all’inizio del Quattrocento43. La prima versione miniata delle Grandes Chroniques era stata voluta da Matteo di Vendôme, abate di Saint-Denis (1258-1286), effigiato insieme con Primate al fº 326, al centro della scena di consegna dell’opera al re. Questa prima redazione e le successive realizzate in maniera crescente a Parigi erano state condizionate dalle esigenze di autorappresentazione che ognuno dei committenti aveva voluto attribuire all’operazione di copiatura e di illustrazione, sia in prima persona, sia attraverso una sorta di maître d’ouvrage che aveva supervisionato la confezione del codice44.
Sono persuasa, però, che ogni paragone tra il Chronicon pictum e le Grandes Chroniques de France sia inadeguato, innanzitutto perché a differenza della Francia, dove già a fine Duecento si assisté a una fioritura spettacolare della langue d’oïl con ricadute importanti sulle narrazioni storiche45, così come sul mercato del libro46, l’ungherese non fu impiegato come lingua scritta colta almeno fino a quando, tra il 1470 e il 1530, si produsse un consistente numero di traduzioni dal latino di testi sacri, biblici e liturgici47. Ma non è soltanto una questione linguistica, di per sé fattore nient’affatto trascurabile. La discrepanza più radicale è nella consistenza quantitativa: circa 75 codici francesi contro un solo codice ungherese. Il manoscritto qui in esame, che – come dicevo – è il testimone più antico di una compilazione cronachistica attestata in 11pochissime altre redazioni tre-quattrocentesche, è l’unico esemplare a esser stato riccamente miniato. L’operazione messa in atto nel Cod. Lat. 404 non costituì, in effetti, il modello di nuove imprese di analogo tipo. Meno che mai ci troviamo di fronte a un’azione di propaganda utile a catturare il consenso ad ampio raggio, quale che fosse il tipo di pubblico prescelto48. Il Chronicon pictum non rappresenta in alcun modo un tentativo di rendere popolare la storia nazionale49, anzi proprio il contrario.
Per chi fu concepito questo manoscritto? In mancanza di pezze d’appoggio per poter anche soltanto ipotizzare l’esistenza di altre copie illustrate, si pone come prioritaria la questione della sua ricezione originaria50. Non c’è dubbio che si tratti di un oggetto di lusso e che il re Ludovico effigiato in maestà e inginocchiato in preghiera con sua moglie sul frontespizio dimostri che siamo di fronte a un’operazione connessa con la famiglia reale51. Ma non abbiamo la certezza che sia stato proprio il sovrano a commissionare il manoscritto miniato a un copista e a un artista, e siamo tenuti a chiederci se l’iniziativa non sia invece partita da un membro del suo entourage o della sua famiglia52. E se anche fosse stato il re a farlo eseguire, questo non implicherebbe che ne fosse il principale destinatario, perché non è detto che il committente e il fruitore fossero la medesima persona: il re potrebbe aver fatto realizzare il manoscritto per sé e/o per un membro della famiglia reale, o qualcun altro potrebbe averlo commissionato per il re o/e per un altro individuo della stessa famiglia. Manca una scena di dedica con la consegna del libro che possa chiarire le parti giocate dai protagonisti della sua fabbricazione53. Quel che invece mi pare sicuro è che il codice si prestasse a più gradi di ricezione, implicanti comportamenti diversi e non sempre concomitanti: si poteva leggere la cronaca54, cercando gli episodi con l’aiuto dei titoli in lettere rosse55; si poteva leggere la cronaca e guardare le miniature56; si potevano soltanto guardare le miniature57. La lettura poteva svolgersi in pubblico58, persino ad alta voce, ma l’azione del guardare non poteva che esercitarsi in privato, perché il manoscritto, per le sue esigue dimensioni, era poco adatto a esser mostrato aperto di fronte a un grande consesso. Se la cronaca offriva un racconto che metteva Carlo I e Ludovico all’apice della storia secolare della monarchia ungherese, in una forma di auto-celebrazione dinastica il cui valore politico è a stento dissimulato, la domanda che mi pongo è che tipo di racconto offrisse il ciclo miniato a chi ne usufruiva usando esclusivamente la vista. 12Ebbene, penso che sia proprio questo il nodo che potrebbe consentirci di rispondere alle questioni finora enumerate, perché le immagini, anche quelle di carattere storico-genealogico, procedono su un binario autonomo persino rispetto al testo a cui sembrano o vogliano rinviare, non solo perché il linguaggio figurativo è dotato di regole distinte da quelle della scrittura, ma perché le miniature potrebbero addirittura esser state ideate per un tipo di ricezione destinato a passare unicamente dal senso della vista.
Il Cod. Lat. 404 contiene, nel suo stato attuale, 146 pagine nelle quali il testo è intervallato da 146 miniature: 43 riquadri geometrici e 103 iniziali in corrispondenza più o meno uniforme con i 103 titoli di capitolo59. Chi possedeva il savoir-faire specialistico per poter concepire una struttura compositiva di tale coerenza? Chi aveva una consapevolezza tale delle capacità espressive delle immagini da poter selezionare le parti testuali da riprodurre figurativamente? E che ruolo ha esercitato l’artista in questo processo? La storia della miniatura medievale ha preso in esame molti esempi in cui i manoscritti ancora conservano le indicazioni date dallo scriba al miniatore per dirgli cosa dovesse fare60. Nel nostro caso non c’è traccia, però, di suggerimenti visibili. Possiamo allora ipotizzare che il concepteur della sequenza visiva, la cui identità non conosciamo, abbia fornito al copista o al miniatore (o a entrambi) una selezione di eventi dal flusso continuo della narrazione, chiedendogli di enfatizzare alcuni aspetti, e che sulla base di questi elementi si sia stabilito come far dialogare scrittura e miniatura nelle pagine del codice. Sarebbe abbastanza ingenuo, infatti, presumere che l’artista avesse letto la cronaca per intero, scegliendo lui stesso la porzione di racconto più adeguata a essere rappresentata, o che avesse, ad esempio, una così grande cultura agiografica da poter prendere dalle vite dei santi quel che considerava opportuno per integrare il racconto cronachistico con elementi narrativi che nella cronaca non c’erano affatto.
Quando diciamo che il miniatore ha tratto un particolare di un episodio illustrato da un’altra fonte testuale diversa dalla cronaca, non dobbiamo in alcun modo dare per scontato che avesse letto quella fonte, ma siamo obbligati a considerare l’eventualità che qualcuno gliela abbia spiegata o piuttosto che egli stesso disponesse di un modello figurativo nel quale quella fonte era già stata utilizzata. Ognuno di questi casi implicherebbe un atteggiamento diverso rispetto al soggetto da rappresentare. 13Qualsiasi ipotesi formuliamo su questo tema dovrebbe avere comunque una credibilità verificata su altri casi europei, ma l’ipotesi che ha meno credibilità di tutte è che il miniatore fosse a conoscenza dell’intera storia ungherese o delle vite dei santi, e abbia deciso in autonomia, senza l’aiuto di un consigliere autorevole, cosa rappresentare in relazione a ciascun capitolo. Sarebbe inoltre altrettanto ingenuo ipotizzare che il miniatore abbia trascritto in immagine un fatto narrato nella cronaca senza immettere in quella trascrizione quel che gli veniva dal proprio bagaglio di formazione e dai modelli che aveva a disposizione61. In verità, non abbiamo nessun dato concreto per dimostrare che la storia dei re d’Ungheria fosse stata già rappresentata prima dell’esecuzione di questo manoscritto: presumibilmente non era mai stata rappresentata nella sua interezza, visto che la cronaca così come si presenta nel Cod. Lat. 404 era stata assemblata soltanto nel 1358, come dichiara il testo rubricato del frontespizio. Ma singoli episodi della vita dei santi Stefano o Ladislao potevano esser stati esposti sulle mura di qualche edificio sacro o civile del Regno d’Ungheria, e di certo erano stati miniati in alcuni codici ora disseminati in Europa e negli Stati Uniti. Il confronto con quei codici dimostra, però, che non costituirono una fonte per il miniatore del Chronicon pictum, né dal punto di vista stilistico, né meno che mai da quello iconografico e compositivo. La versione in immagini della storia dei re d’Ungheria del manoscritto qui in esame è un unicum.
Per materializzarsi nell’oggetto-libro, una cronaca illustrata o picta impiegava un sistema di segni appartenenti alla cultura del committente, dell’ideatore della struttura e dell’artista, e da tutti loro condivisi62. Il manoscritto andrebbe pertanto studiato come il risultato di un’operazione la cui coerenza è data dalle sue specifiche modalità di confezionamento. Mi interessa capire come le informazioni di natura storica, sociale e politica siano state trasposte in immagine63, o quali strategie siano state usate dal miniatore per rendere la concezione della sovranità e della storia ungherese che avevano Ludovico il Grande o i membri della sua famiglia e della sua corte negli anni intorno al 1358. Ma non mi interessa soltanto questo, perché il Chronicon pictum è paradossalmente molto di più di una cronaca miniata. Per realizzarlo non fu sufficiente un procedimento meccanico di trasferimento da un medium all’altro, perché sugli eventi storici fu operata una scelta meditata e soprattutto furono immessi altri elementi narrativi, che potrebbero sembrare addirittura 14superflui se volessimo circoscrivere la nostra interpretazione al contesto politico. Forse dovremmo cominciare a pensare che fossero stati previsti non solo più gradi di fruizione del manoscritto, intellettuali e sensoriali64, ma che il codice fosse stato concepito su più registri formali: lo storico e il politico, ma anche, e non in contrapposizione, l’eroico, il fantastico, e persino il fiabesco65.
Nel titolo parlo di «Cronaca angioina», non solo perché il Chronicon pictum fu compilato e illustrato nell’Ungheria che storiograficamente chiamiamo angioina, ma perché non sarebbe concepibile al di fuori dello spazio politico europeo così abitualmente definito. Con il sintagma «dei re d’Ungheria» intendo sottolineare che, se si escludono i soldati, masse senza volto, emanazione dell’istituzione monarchica da cui dipendeva la loro esistenza, i protagonisti delle miniature sono indiscutibilmente i sovrani. Persino nelle tre tabelle con la duplice migrazione degli antenati e l’ingresso delle diversæ nationes giunte dall’esterno, l’accento è posto sullo statuto aristocratico e cavalleresco dei responsabili delle migrazioni, antenati dei re e dei nobili, individui di grande eroicità situati al vertice della scala sociale66. Una tradizione cronachistica ormai stratificata si tradusse, pertanto, in immagini in cui la migrazione, elemento essenziale nella formazione del regno67, si pose come il termine primo di una storia il cui termine ultimo era proprio l’arrivo di un re angioino che, sposando Elisabetta di Polonia68, aveva generato un figlio, Ludovico, destinato dalla nascita a essere «grande». Quando parlo, infine, di specchio eroico e fiabesco della sovranità, intendo sottolineare il dato che immediatamente colpisce l’occhio del riguardante che apre il manoscritto: l’enfasi posta sul personaggio-eroe e l’atmosfera da fiaba che sembrano aver concorso alla realizzazione del manoscritto tanto quanto l’aspirazione politica a inserire in una cornice storica le origini della dinastia regnante e del regno stesso.
Per indagare le questioni e i temi qui sintetizzati, ho diviso il volume in tre capitoli. Il primo capitolo è dedicato a spiegare come avvenne il passaggio dinastico da Napoli alle terre ungheresi e quali strumenti simbolici furono impiegati per corredarlo di legittimità, una premessa che ho ritenuto indispensabile per la comprensione del contesto di realizzazione del Chronicon pictum. Fu Carlo I d’Angiò, re di Sicilia dal 126669, a volere il matrimonio di suo figlio con una principessa ungherese, e fu Carlo II a fare in modo che il nipote, anch’egli di nome Carlo, 15lasciasse Napoli per acquisire la corona d’Ungheria. Il giovane Carlo, per quanto in linea femminile discendesse dalla stirpe dei re santi e fosse stato allevato fin da bambino per salire sul trono del Regnum Hungariæ, non era però ungherese di nascita e c’era forte la necessità di costruire la sua immagine come re d’Ungheria anche attraverso un uso politico delle opere d’arte. L’analisi delle relazioni tra i due regni, insieme alla loro fortuna storiografica medievale e moderna, costituisce un antefatto ineludibile per comprendere l’operazione di scrittura e di miniatura del Chronicon pictum.
Nel secondo capitolo si ricostruisce la storia post-medievale del codice dalla sua apparizione a Vienna nei primi cataloghi della biblioteca imperiale fino a oggi. Se il dialogo tra Medioevo napoletano e Medioevo ungherese è indispensabile per comprendere le ragioni che spinsero i committenti a far allestire il manoscritto nella forma in cui oggi si presenta, il dialogo tra Medioevo ed Età moderna è il fil-rouge che sostanzia queste pagine. Nonostante la bellezza delle miniature e la loro alta qualità formale, e malgrado che lo storico dell’arte austriaco Hermann Julius Hermann, suo primo descrittore, vedesse nell’apparato illustrativo del codice uno dei migliori risultati della miniatura italiana del Trecento70, riconoscendovi all’opera un artista proveniente dalla Napoli angioina, va inoltre sottolineato che il manoscritto non è mai entrato nella letteratura specialistica sulla miniatura napoletana, neanche come termine di confronto71. Ad eccezione di Hermann, quasi non si conosce voce bibliografica che non sia ungherese72, un dato giustificabile non soltanto con la percezione patrimoniale identitaria che in Ungheria si è avuta del Chronicon pictum tra Ottocento e Novecento, ma anche attraverso un sostanziale scollamento tra gli àmbiti storiografici delle nazioni uscite dalla Prima guerra mondiale.
Nel terzo capitolo si esamina la struttura del codice, la mise-en-page, le iconografie, le composizioni, la cultura formale, i registri figurativi, le istanze del concepteur e le attese del destinatario. L’operazione usuale (e talora forse abusata) nella pratica storico-artistica del confronto testo-immagine non funziona bene, però, con il Chronicon pictum, perché la cronaca e le miniature dialogano quasi esclusivamente per mezzo dei titoli rubricati, che nella maggior parte dei casi non riassumono il contenuto dei capitoli, ma il senso del racconto figurativo. Per non ridurre, quindi, quel confronto a un mero rapporto di causa-effetto, e 16per non banalizzare l’operazione di trasferimento degli eventi storici nelle miniature, ho cercato di smontare il meccanismo in base al quale il manoscritto fu organizzato, analizzando separatamente i pezzi emersi dall’indagine e poi rimontandoli insieme. Il libro si completa con un catalogo delle miniature, descritte singolarmente.
Alcune precisazioni redazionali. In materia di toponomastica, per la quale non esistono scelte neutre dal momento che ogni decisione è inevitabilmente ideologica anche quando pretende di non esserlo, ho cercato di rendere in italiano la forma latina o latinizzata che i nomi di luogo assumono nelle fonti medievali (e allo stesso modo mi sono comportata per i nomi di persona). Qualora questo procedimento non risultasse agevole, ho evitato di usare i toponimi attuali, che tenderebbero a snaturare il discorso storico, dal momento che l’Ungheria post-Trianon corrisponde in minima parte all’Ungheria medievale e che molti dei siti citati nelle fonti ungheresi si trovano oggi in altri stati, e ho preferito le forme antiche attestate testualmente. Nelle trascrizioni delle fonti latine, narrative, epigrafiche e archivistiche, ho sciolto le abbreviazioni, intervenendo sulle maiuscole e le minuscole, sulla punteggiatura e sui dittonghi æ e œ, per rendere più fruibile la lettura.
Il lettore mi consentirà a questo punto qualche rapidissima nota di ego-histoire. Per chi come me ha studiato e ancora studia la Napoli angioina sia dal punto di vista monumentale che storiografico, l’Ungheria medievale è una realtà storica e artistica con la quale ho sempre ritenuto di dover fare i conti. Nel 2010 fui invitata a svolgere le mie ricerche sui riflessi artistici delle relazioni politiche tra il Regnum Siciliæ e il Regnum Hungariæ presso il Collegium Budapest, ma proprio quell’anno quella magnifica istituzione chiuse le sue porte per sempre, e l’Institute for Advanced Study appena fondato dalla Central European University ne prese virtualmente il rilievo73, assegnandomi una fellowship per un progetto dal titolo The Artistic Patronage of Robert (1309-1343) and Charles Robert of Anjou (1309-1342) between Naples and Hungary: A Comparative Study74. Da quel momento la cultura ungherese, anche letteraria75, è diventata parte essenziale dei miei interessi intellettuali e l’Ungheria medievale il focus delle mie ricerche scientifiche76. Man mano che ho proceduto nelle indagini, incrociando i fatti napoletani con quelli ungheresi, i diversi pezzi si sono venuti a incastrare gli uni accanto agli altri permettendomi di comporre un quadro derivato non solo dall’analisi delle opere d’arte e 17delle funzioni extra-artistiche a esse assegnate dai rispettivi committenti, ma anche dall’esame della fortuna post-medievale di quelle opere e dello sguardo che la storiografia aveva dato dei relativi contesti storici.
Studiando Napoli e l’Ungheria insieme, non poteva non saltarmi all’occhio come nel Chronicon pictum la storia dei re ungheresi avesse trovato un apice quasi teleologico nel re napoletano che si era dichiarato arpadiano e nello stesso tempo angioino. Sulla base di tali premesse, questo libro si apre su Napoli e su Napoli si chiude. L’esame delle miniature del manoscritto, prima lenticolare, poi a distanza, prima dall’Ungheria, poi da Napoli e dall’Europa, mi ha permesso di individuare una serie di dati che mi hanno fatto sospettare che, al di là delle indiscusse intenzioni auto-rappresentative della monarchia, possano esservi stati altri moventi più personali (il che non significa meno politici) alla base della sua realizzazione. Alla cultura ungherese della metà del Trecento, che aveva adottato le cantilene dei ioculatores e le antiche saghe, divertissements retoricamente deprecati dai suoi letterati ma ugualmente diffusi a corte e tra le élites del regno, ipotizzo, infine, che si possa imputare la scelta del tono eroico e fiabesco che informa di sé il Cod. Lat. 404, costituendone la cifra dominante.
Desidero esprimere la mia gratitudine al personale della Országos Széchényi Könyvtár di Budapest, in particolare modo a Ferenc Földesi, direttore della collezione dei manoscritti, e ad Anna Boreczky. Ringrazio molto anche Judit Lauf, del gruppo di ricerca MTA-OSzK Res Libraria Hungariæ per il suo aiuto a distanza.