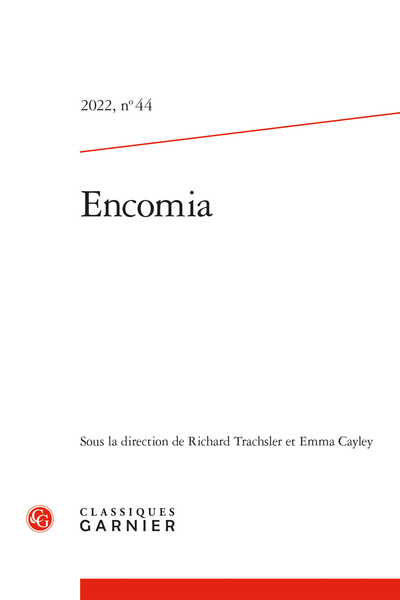
La funzione sociale dell’abbigliamento Regole e convenzioni nel Gouvernement des roys et des princes, tra letteratura e politica
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Encomia
2022, n° 44. varia - Auteur : Scala (Gavino)
- Résumé : L’objectif du présent article est de fournir de nouvelles observations sur la fonction sociale de l’habillement dans Le Livre du gouvernement des roys et des princes (première traduction française du De regimine principum de Gilles de Rome), compte tenu des règles et des conventions sur la façon de s’habiller qu'il contient, étroitement liées au contexte politique de la cour de France à la fin du xiiie siècle.
- Pages : 157 à 171
- Revue : Encomia
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406167266
- ISBN : 978-2-406-16726-6
- ISSN : 2430-8226
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16726-6.p.0157
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 24/04/2024
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Italien
- Mots-clés : manuscrits, specula principis, costumes, cour, ordonnances, lois somptuaires
La funzione sociale dell’abbigliamento
Regole e convenzioni nel Gouvernement des roys et des princes, tra letteratura e politica
Considerare la codificazione dell’abbigliamento in un testo appartenente al genere degli specula principis significa accorpare una serie di regole e convenzioni concepite per essere applicate all’intero assetto gerarchico di corte, in particolare a quella serie di figure che gravitano intorno alla figura del re (donne, prole, funzionari). L’insieme di tali regole, fatte dialogare con le decisioni politiche coeve, ci danno un’idea sul rispetto, etico e morale, della condotta di corte per ciò che concerne il vestiario.
In questa sede, ci si focalizzerà sul De regimine principum (1277–1280) di Egidio Romano e sulla sua prima traduzione francese, Le Livre du gouvernement des roys et des princes (1282) di Henri de Gauchy,1 per comprendere ed analizzare i passaggi dell’opera consacrati all’aspetto del vestiario di corte. In seguito, questi elementi testuali saranno collegati al contesto politico di corte di riferimento ed alle decisioni ufficiali dei re di Francia sul tema dell’abbigliamento e dei costumi.
Non sorprende il fatto che riferimenti ad un modo virtuoso di vestirsi trovino spazio nel De regimine principum,2 trattato didattico-morale sull’educazione e sulla formazione del principe, eseguito da Egidio 158Romano su ordine del re di Francia Filippo III l’Ardito e dedicato a suo figlio, il futuro re di Francia, Filippo IV il Bello. Suddiviso in tre libri, il testo rappresenta anche una tappa importante nel processo di trasmissione del pensiero aristotelico nel Medioevo, rispettando la tripartizione canonica dello Stagirita.3 Considerata l’influenza politica e culturale dell’opera, lo stesso re di Francia ne ordina una traduzione in francese, probabilmente per estendere i contenuti ad un pubblico di corte che ormai non padroneggiava più il latino, sempre con lo scopo di formare ed educare una società perfetta. Questa traduzione, eseguita a corte qualche anno dopo da Henri de Gauchy, canonico di San Martino di Liegi, ad oggi è trasmessa da trentanove manoscritti ed è leggibile nell’edizione del 1899 di S. P. Molenaer.4 Tuttavia, recenti ricerche hanno permesso di riaggiornare lo stato dell’arte sulla tradizione e proporre nuovi criteri editoriali (Scala 2021); pertanto, in questa sede il testo sarà citato a partire dal manoscritto Modena, Biblioteca Estense Universitaria, alfa.p.04.17 (ex est.43; siglato M), ritenuto tra i più affidabili della tradizione.5
Tornando alla funzione sociale dell’abbigliamento, va anzitutto specificato che nel Gouvernement tale concetto è strettamente legato al tema dell’educazione e soltanto raramente si ritrovano dettagli sulle specifiche tipologie d’abbigliamento (praticamente mai, invece, si ritrovano dettagli sui colori e sui materiali del vestiario). Il testo, infatti, si focalizza piuttosto su modelli indicativi per evitare, ad esempio, manifestazioni di esuberanza e lussuria. Infatti, riferimenti al modo di vestirsi sono presenti e concentrati soltanto nel secondo libro, il cui tema è proprio la gestione della corte e l’educazione dei suoi membri (de regimine domus); le tre parti di questo secondo libro, rispettando la struttura del suo modello latino, sono quindi consacrate rispettivamente alle donne, alla prole ed ai funzionari di corte.6 Si vedranno, perciò, le 159regole e le convenzioni per ciascuna categoria, analizzando di volta in volta il rapporto tra fonte7 e volgarizzamento per evidenziare, oltre agli eventuali scarti e differenze, il modo di rendere in francese la densa prosa egidiana a proposito dell’abbigliamento di corte. Tracciare un quadro completo servirà anche ad inserire queste considerazioni all’interno del più vasto discorso sull’abbigliamento nel Medioevo.8
In primis va detto che lo scopo dell’assetto di regole presentato nel Gouvernement serve a costruire eticamente la base della comunità, come menzionato nel passaggio seguente:
La seconde reson si est quar, ja soit ce que nature ait donné aus bestes et aus oisiaus soufisaument naturel vesteure, si comme lainne et penne et peus; toute voies nature n’a pas porveu l’omme soufisaument de vesteure, ainz couvient que l’omme, por ce qu’il est de plus noble complexionet puet plus tost estre bleciez d’aucunne chaleur ou d’aucune froidure que les autres bestes, il covient que ses vesteures soient diligenment et soutiment apareilliees. Et a ce fere une seule personne ne puet soufrir, si comme il apert dont, et por la viande et por la vesteure dont l’omme a besoing, il couvient que l’omme s’encline par nature a vivre en communeté et encompaignie. (Gouvernementii i i, ms. M, f. 36v)
Secunda via ad investigandum hoc idem, sumitur ex parte indumentorum, quibus tegimur. Nam sicut natura sufficienter aliis animalibus providere videtur in victu: sic videtur quod eis sufficienter provideat in vestitu. Bestiae enim, et aves, quasi naturale indumentum, habere videntur lanam, vel pennas. Homini autem non sufficienter providet natura in vestitu: cum enim homo sit nobilioris complexionis quam animalia alia, a frigiditate et ab intemperie temporis magis habet offendi, quam illa; quare cum habere victum et vestitum congruat ad vitam humanam, et nullus sibi sufficiat sine societate alterius, sequitur quod homo naturalem impetum habeat ut sit animal sociale. (De regimine ii i i, ed. 1607)
Lo scopo di procurare e procurarsi vestiti, in modo solidale, caratterizza l’uomo in quanto animale sociale e parte attiva ed integrante di 160una comunità: egli si mette a servizio della società per contribuire al suo funzionamento e, all’occorrenza, provvede anche a produrre e confezionare capi d’abbigliamento per sé e per il prossimo. Si evidenzia la funzione sociale9 del dotarsi di vestiti, ovvero la protezione e la custodia del corpo umano (e della comunità in generale). Inoltre, non sorprende la prima posizione riservata ai capi in lana, materiale primario per la produzione di abiti durante il Medioevo, nonostante il confezionamento e l’aspetto dovevano presentare sostanziali differenze a seconda della categoria sociale.10
Invece, nella prima parte del secondo libro, dedicato alla figura della donna in quanto sposa del re, a più riprese si menzionano norme comportamentali sul vestiario e sugli orpelli adatti alle donne di corte.11 Questi devono essere, in sostanza, obbligatoriamente sobri e non devono mai cadere nell’eccesso:
Ce .xviii.me chapistre enseigne coument les fames mariees doivent leur cors aourner de vesteures et d’autres choses.
[…] quar fames desirrent mout qu’eles semblent estre beles et por ce eles pechent mult souvent en eles aourner, quar eles cuident par leur aournemenz senbler estre beles. (Gouvernementii i xviii, ms. M, f. 44v)
Quomodo foeminae coniugatae circa ornamentum corporis debeant se habere. Cap. XXI.
[…] cum ergo mulieres ut plurimum appetant videri pulchrae, potissime delinquunt circa ornatum corporis. (De regimine ii i xxi, ed. 1607)
Spesso le donne, secondo Egidio Romano, utilizzano una grande varietà di abiti con lo scopo di apparire e sembrare più attraenti. Significativo è il passaggio in cui si menziona il divieto di usare il ‘fart’,12 in latino ‘fucatio’, cioè ciò che in italiano corrente viene comunemente chiamato ‘phard’:
Li uns si est que l’en apele fart, de quoi les fames se oingnent et se demoustrent plus vermeilles et plus beles ou plus blanches que eles ne sont. Li autres aournement si est en avoir vesteures et autres aournement, lesquielz sont 161honnestes et les doit l’en souffrir, se les fammes le font ordeneement selonc leur estaz et leur conditions. Dont il afiert a touz houmes que eus porvoient leur fames de vestemenz avenanz et d’autres aournemenz selonc leur pooir et leur estat. (Gouvernementii i xviii, ms. M, f. 44v)
Fictitius autem ornatus dicitur fucatio, ut appositio coloris albi vel rubei: quibus per quaedam figmenta ostendunt se foeminae rubicundiores, vel albores, vel alio modo pulchriores, quam sint. Talia autem quae sunt fictitia et sophistica sunt illicita et prohoibenda. Alius autem est ornatus non fictitius, qui consistit in debitis indumentis, et in aliis ornamentis, quae si considerato proprio statu et conditionibus personarum debite et ordinate fiant, sunt licita et honesta. Decet enim viros secundum suum statum, suis uxoribus, in debitis vestimentis, et in aliis ornamentis, debite providere. (De regimine ii i xxi, ed. 1607)
Esso è proibito in quanto altera e modifica il naturale colore della pelle.13 Per quel che riguarda l’abbigliamento, invece, le donne devono scegliere il vestiario in accordo con la propria classe sociale: la sposa di un cavaliere sarà vestita meglio della sposa di un popolano, ma risulterà meno elegante se confrontata con la moglie del re. Inoltre, è l’uomo a dover procurare vestiti ed ornamenti per le proprie donne.
Le tre virtù da rispettare per essere vestite appropriatamente sono quindi l’umilità, la moderazione e la semplicità,14 evitando in ogni modo la vanità (‘vanam gloriam’) e la lussuria:
Dont a ce que les fames ne facent pechié en eles trop vestir et aourner, il covient que eles aient trois vertuz. L’une si est humilité quar, quant les fames s’aournent belement, non pas por la vaine gloire du siecle, mes pour plere a leur mariz et por eus retrere de pechié de fornication, eles sont humbles. […] aucunes genz ne se vestent pas ne aornent si comme il devroient, et ne le 162lessent pas por peresce, ne par negligence, ainz le lessent por ce que de leur vil habit et lait, il aient la loenge et la vaine gloire du siecle; et bien avient aucune foiz que tel gent de leur chaitiveté enorgueillissent et de leur habit qu’il ont. (Gouvernementii i xviii, ms. M, ff. 44v–45r)
Huiusmodi triplex virtus, est humilitas, moderantia, et simplicitas. Tunc enim mulieres circa ornatum corporis sunt humiles, quando non propter vanam gloriam se ornant, sed agunt ut suis viris placentes, eos a fornicatione retrahant. […] Secundo in talibus delinquitur, si ex ipso defectu quaeratur laus et gloria. Contingit enim aliquando aliquem efferri et superbiri ex ipsa miseria, quam sustinet. […] sic aliquando qui vilior est in habitum, magis superbus efficitur, si credat ex hoc ab hominibus commendari. Delinquunt igitur mulieres, si ex vilitate habitus, et ex defectu vestrum gloriam quaerant. (De regimine ii i xxi, ed. 1607)
Rispettando questa prima virtù esse, inoltre, contribuiscono a prevenire il marito dai peccati carnali; il corpo femminile, infatti, è percepito come oggetto di desiderio sessuale e pertanto la nudità, anche parziale, accentua la fragilità naturale della figura femminile15 e la conduce verso il peccato. Dall’altro lato, invece, devono evitare anche qualsiasi manifestazione di incuria, sciatteria o trascuratezza. Altra considerazione interessante riguarda la consapevolezza che, talvolta, donne vestite impropriamente si mostrano orgogliose e fiere dei propri abiti, pensando di essere apprezzate dalle altre persone; coscienti di ciò, invece, dovrebbero evitare anche questo possibile scenario.
Tra l’altro, sulla condotta della donna e sulla sua formazione morale e spirituale, proprio a corte di Filippo IV circola parallelamente un altro testo, lo Speculum dominarum, eseguito da Durand de Champagne negli stessi anni del De regimine principum. Dedicato alla regina Giovanna di Navarra (di cui Durand era confessore), il testo conoscerà la stessa sorte del trattato egidiano e sarà tradotto in francese poco dopo su ordine della stessa regina: è datata al 1285 circa la traduzione (anonima) del testo, che prende il titolo di Miroir des dames. Se di quest’ultimo non esiste un’edizione critica,16 quella del modello latino è stata recentemente pubblicata.17 In futuro sarebbe interessante allargare queste prospettive 163di ricerca e passare in rassegna in sinossi anche questi due testi in modo da verificare se tra i principi morali e spirituali di Durand vi siano anche riferimenti alla condotta da tenere ed al modo di abbigliarsi delle donne di corte. Da un rapido sondaggio delle rubriche (effettuato sul codice Paris, Bibliothèque Nationale de France, français 610) non vi sono esplicite sezioni consacrate all’abbigliamento nello specifico, restando il testo principalmente impostato sul piano morale e spirituale, sul rispetto delle virtù e sulla materia liturgica; tuttavia, si intravedono comunque accenni al modo di abbigliarsi, come ad esempio:
Mulieres in habitu ornato cum verecondia et ceteri. Lez femmes, dit il, en leur atour et en leur abit doivent estre vergongneuses et sobres, sans excés et sans oultrageuse curiosité, laquelle selon la verité est en moult de femmes a leur dampnement. De ceste vergongne parle le saige. (Mirois des fames, ms. Paris, Bibliothèque Nationale de France, français 610, f. 65v)
Ancora una volta si rimarca il divieto degli eccessi, ai quali va preferito un profilo sobrio e moderato. I principi morali qui espressi sembrano in linea con quelli del Gouvernement e tale vicinanza la si rileva anche dal punto di vista narrativo e linguistico; ci si auspica, pertanto, di rintracciare in futuro ulteriori elementi di contatto che possano ampliare questo discorso e far dialogare i due specula, i quali sembrano essere parte della stessa costellazione, sia da un punto di vista del genere (letteratura didattica) sia per ciò che concerne l’impostazione metodologica (vi è un modello latino seguito da una traduzione francese voluta dal re o dalla regina), acquisendo un’importanza anche sul piano politico.
Tornando al secondo libro del Gouvernement, così come per le donne, anche per i rampolli di corte18 risulta importante seguire una ferrea condotta con lo scopo di educare un futuro gentiluomo:
Ce .xiii.me chapistre enseigne coument les enfanz se doivent contenir en joer et en mouvoir leur menbres et en aus vestir.
[…] nous dirons comment il se doivent avenaument contenir en eus vestir, por quoi l’en doit savoir que l’en quiert les aournemenz et les robes por trois choses, et por avoir delit et enneur et por avoir proufit. Dont se l’en quiert les robes por avoir delit, l’en les quiert molles et delicieuses; et se l’en les quiert por proufit du cors, l’en les quiert chaudes ou froides, selonc ce que li tens 164le demande; et se l’en les quiert por avoir honneur l’en les demande beles et avenanz. (Gouvernementii ii xiii, ms. M, ff. 53r–53v)
Qualiter iuvenes se habere debeant in ludis, et in gestibus, et in vestitu.
[…] Omne enim bonum vel est delectabile, vel utile, vel honestum sive honorabile. Bonum enim honestum, bonum honorabile dici potest: nam honestum idem est, quod honoris status. Si ergo vestimenta quaeruntur propter bonum delectabile: sic quaeruntur delicata, et mollia. Si propter utile: sic quaeruntur calida ad repellendum frigus tempore hyemali, vel non calida tempore aestivo. Si vero quaerantur propter bonum honorabile: sic quaeruntur pulchra, et decora. (De regimine ii ii xiii, ed. 1607)
Gli abiti per i giovani cortigiani sono scelti in base a tre parametri: delectationem, utilitatem ed honorem. Se i capi d’abbigliamento sono scelti in base al primo parametro, cioè per puro piacere, essi saranno ‘delicata et mollia’ (‘molles et delicieuses’ in francese); se essi sono scelti per essere utili (‘por proufit du cors’), bisognerà tener conto quindi della temperatura ed adattarli a climi caldi o freddi. Se, invece, sono scelti per occasioni formali e per essere quindi rispettabili, essi saranno belli e decorosi.
Anche nel caso dei giovani, le regole sono da rispettare con lo scopo di evitare qualsiasi tipo di peccato e di comportamento disonorevole:
Et desafiert mout estre trop curieus en querre robes trop moles et trop delicieuses et por .ii. resons. La premiere si est quar celi qui ce fet est desatrempez et n’est pas hons viguereus, ainz est trop mous et trop feminins; et volentiers s’encline a joliveté et a fere les oevres de luxure. La seconde reson si est quar cil qui quiert robes trop moles et trop delitables, il resoigne les armes a porter, qui sont dures et aspres, por quoi il devienent pooreus. Dont quant les enfanz vienent a l’aage la ou il sont avables a souffrir aucuns travaus de bataille, l’en les doit enseignier que il ne quierent pas trop moles robes, ne trop delicieuses vesteures, por ce qu’il redoutent a porter les armes. (Gouvernementii ii xiii, ms. M, f. 53v)
Indecens est autem nimis solicitari circa molliciem vestium, et circa delectationem in ipsis: nam ex hoc efficitur quis intemperatus et timidus. De levi enim quis ad lasciviam et ad molliciem carnis prorumpit, si nimis delectetur in mollicie vestrum, et circa delectationem in ipsis. Videntur enim tales esse muliebres magis, quam viriles; quare non sunt constantes, sed molles et de facili in lasciviam prorumpunt. Secundo, nimia mollicies vestium reddit hominem timidum. Nam cum arma ferrea in se quandam duriciem habeant, qui semper solicitantur circa mollia vestimenta, dubitant arma arripere, et efficiuntur timidi. Iuvenes, maxime cum ad aliam aetatem venerint, ad hoc quod sint habiles ad vacandum circa labores bellicos, ne abhorreant arma, 165instruendi sunt, ut non nimis delectentur in mollicie vestium. (De regimine ii ii xiii, ed. 1607)
In particolare, vestiti ‘moles’,19 ovvero licenziosi rendono la persona poco virile, debole, effeminata ed incline ad atti lussuriosi. Il termine latino ‘mollis’,20 da ‘mollitia’, in francese reso con ‘mole’, probabilmente si riferisce anche all’aspetto materiale e quindi alla resistenza degli abiti, che invece dovrebbero essere duri, forti, spessi e pesanti in modo da sopportare e reggere, moralmente e fisicamente, il peso delle armi. Nell’ultima parte del capitolo di riferimento, prima Egidio Romano, poi il suo traduttore, parlano dei diversi capi d’abbigliamento scelti in base alla stagione, alle diverse età ed alle diverse corporature. Un altro aspetto interessante riguarda, invece, la scelta del vestiario nel rispetto, non solo della propria condizione sociale, ma anche delle tradizioni della propria patria:
Et est a savoir que se l’en quiert les robes et les vesteures por avoir honneur, l’en doit regarder la coustume du païs et les condicions des persones, quar selonc ce que la coustume du païs et selonc les condicions des persones, li hons et la fame doivent querre beles robes et honorables. (Gouvernementii ii xiii, ms. M, f. 53v)
Vestimenta igitur, considerata proprietate temporum, complexionum, et aetatum, diversificanda sunt, ut deserviunt ad bonum utile. Sed ut deserviunt ad bonum honorabile, attendenda est consuetudo patriae, et conditio personarum. (De regimine ii ii xiii, ed. 1607)
Nella terza parte del secondo libro, dedicata al rapporto con la servitù, vi è un intero capitolo dedicato alla tematica dell’abbigliamento; re e principi devono infatti procurare il vestiario ai propri funzionari in modo da dimostrare lo splendore della corte, che apparirà quindi onorevole e generosa, evitando in ogni caso manifestazioni di pomposità e vanità:
Ce quinsieme chapistre enseigne coument les rois et les princes doivent porveoir robes et vesteures a leur sergenz et a leur mesnie.
[…] il afiert a eus que il [les rois et les princes] porvoient de beles robes et de biaus aornemenz, ne mie por eus mostrer ne por vaine gloire, mes por leur grant estat garder et por ce que li pueples ne les ait en despit. (Gouvernementii iii xv, ms. M, ff. 64v–65r)
166Quomodo a regibus et principibus providenda sunt indumenta ministris.
Cum enim deceat regem esse magnificum, ut supra in primo libro diffusius probabatur, decet ipsum erga suos ministros decenter se habere in apparatu debito, et in debitis indumentis. Nam licet non ad inanem gloriam, nec ad ostentationem talia sint fienda: tamen ut reges et principes conservent se in statu suo magnifico, et ne a populis condemnantur, decet eos magnifica facere. (De regimine ii iii xvii, ed. 1607)
Tutti i membri della corte devono quindi essere vestiti allo stesso modo; tuttavia, coloro di un grado sociale maggiore hanno il diritto di indossare un capo diverso per distinguersi dagli altri membri della stessa classe sociale, di inferiore livello. Tale regola è applicabile allo stesso modo sia per coloro che ricoprono cariche religiose, sia per i laici:
Selonc les condicions des sergenz et des services ou il sont, l’en leur doit donner diverses robes, quar en si grant mesons comme sont les mesons des rois et des princes, aucuns sont laÿs et aucuns sont clers; et entre les clers et les laïs sont aucuns plus dignes et plus souverains les uns que les autres. Dont tot les laïs et tout les clers ne doivent pas estre vestuz ne aornez de unes meesmes robes, ainz doivent les meilleurs et les souverains estre vestuz mielz et plus honorablement que les autres. (Gouvernementii iii xv, ms. M, ff. 64v–65r)
Tertio circa provisionem indumentorum consideranda est conditio personarum. Nam non omnes decet habere aequalia indumenta. In tantis enim domibus non solum sunt laici, sed etiam clerici: et inter utrosque quidam superiores, et quidam inferiores: propter quod decet eos aliter et aliter esse ordinatos. Quare in domibus regum et principum, quarum quaelibet propter varietatem ministantium et officiorum quasi quoddam universum dici potest, non omnes ministrantes aequae pulchro apparatu, nec aeque pulchris indumentis gaudere debent, sed considerata conditione personarum sic secundum suum statum cuilibet sunt talia tribuenda, ut in hoc appareat providentia et industria principantis. (De regimine ii iii xvii, ed. 1607)
Come per i giovani cortigiani, anche per la servitù si menziona la licenza di indossare abiti che rispettino ‘la coustume du païs’ (‘consuetudo patrie’), in linea con le tradizioni della propria patria: infatti, normalmente, le persone tendono ad usare ed a preferire vestiti e modi di fare (ad esempio, il modo di parlare) tipici del loro paese e dovrebbero quindi rispettarli, a meno che queste usanze non risultino o vengano percepite scortesi ed irrispettose.
La quarte chose que l’en doit regarder si est la coustume du païs, quar toute chose qui n’est pas acoustumee senble estre lede et desordenee, et a l’en grant 167affection a ce que l’en a acoustumé en jonesce. Dont nous veons quemunement les hommes avoir si grant affection as coustumes de leur propre païs, que, ja soit ce qu’eles soient pires et plus ledes que les autres, toute voies quemunement il leur senble que leur coustumes et leur conversations soient plus beles que les autres, por quoi et en robes et en conversation l’en doit garder en aucune maniere les coustumes de son païs, s’eles ne sont trop mauveses et trop deshonnestes. (Gouvernementii iii xv, ms. M, f. 65r)
Quarto circa hoc consideranda est consuetudo patriae. Nam omne inconsuetum videtur quasi turpe et inordinatum: quae enim a pueritia soliti sumus videre, nimis afficimur ad illa. Ideo dicitur circa finem 7. Polit. quod semper prima magis amamus. Videmus enim communiter homines adeo affici ad patrias consuetudines, et ad conversationes regionis propriae, ut etiam si peiores et turpiores sint, eas pulchriores et meliores iudicant. In indumentis igitur, et in omnibus conversationibus aliquid dandum est consuetudini regionum, nisi consuetudines illae sint penitus corruptelae. (De regimine ii iii xvii, ed. 1607)
Da quanto espressamente menzionato nel Gouvernement, il modo di abbigliarsi rappresenta un elemento importante per dimostrare che la corte, e la società in generale, funzionano bene e rispettano moralmente e gerarchicamente gli ordini sociali, anche nel modo di vestirsi. Questo sistema di regole collega, di fatti, la regalità e la corte con l’intero regno, facendo quindi dialogare sfera privata e sfera pubblica. Inoltre, tali regole mostrano l’attenzione rivolta dal re verso il modo di abbigliarsi ed il modo in cui la corte si presenta e viene rappresentata: gli incontri e le cerimonie ufficiali sono infatti i momenti principali in cui si manifesta la dignità ed il prestigio di una corte.21 E per comprendere ancora più a fondo questo tipo di connessioni, dove il dato sul vestiario si pone a metà strada tra letteratura e politica,22 bisogna quindi riferirsi anche ad alcune decisioni politiche prese durante le reggenze di Filippo III e Filippo IV: entrambi, infatti, pubblicano, rispettivamente nel 1279 e nel 1294, due ordonnances somptuaires con lo scopo di regolare ufficialmente alcuni costumi del regno. Importanti e brillanti considerazioni a tal 168proposito si ritrovano nei contributi di Gil Bartholeyns.23 I testi delle due ordinanze24 seguono ancora una scala gerarchica precisa, specificando alcune regole per ogni singola categoria (si va dai prelati ai borghesi, passando per i baroni e per i proprietari terrieri; per ogni categoria, se necessario, si includono anche le donne e i servi).25 Ad ogni categoria si applica, inoltre, il criterio delle rendite annuali, che definiscono quindi l’ammontare delle pene e delle penalità in caso di mancato rispetto delle regole. Ai diversi livelli della scala, le distinzioni si basano su tre parametri: la quantità (il numero di vestiti autorizzati annualmente, per ogni singola persona), la qualità (il prezzo ed il valore dei capi d’abbigliamento) e le istruzioni riguardo i materiali consentiti e quelli proibiti (ad esempio l’oro e le pellicce per alcune categorie sociali).26
Ad esempio, analizzando un passaggio testuale della prima ordinanza del 1279, pubblicata da Henri Duplès-Agier,27 si apprende che alla borghesia non è consentito indossare due tipi di pellicce28 (‘ne vair ne gris’, ovvero due pelli di scoiattolo di diverso colore), così come non è consentito l’uso di alcuni accessori,29 come la bardatura, spesso finemente decorata, utilizzata per cavalcare i cavalli e gli speroni d’oro:
Item que nus bourgois ne porte ne vair ne gris, se il n’a vaillant mil livres de tournois que en terre que en mueble, et cil ne pourra avoir que une robe ensamble, et ne porteront li bourgois dès ore en avant ne lorains ne esperonsdorez. Et que nus bourgeoise ne puist avoir ensamble que une paire de robe vaire outre une autre robe, se elle a eue à son premier mariage, ne dont l’aune de Paris coste plus de xxv s. de tournois. Et se aucuns bourgois faisoit contre cet atirement ou aucune bourgoise, li bourgois, pour son forfait ou pour le sa fame, paieroit xx libr. de tournois, et se la bourgoise n’avoit mari, ele meime les paieroit. Et que nule dame ne damoisele, en quel estat que ele soit, ou conbien 169que ele soit grant dame, ne puisse avoir ensamble que iiij paires, si ele n’est fame ou fille de home qui ait plus de vm livrées de terres à tournois, ou se ele meimes ne les a; et cele ne pourra avoir au plus que v pères de robes, ne de plus grant pris que de xxx s. de tournois l’aune à l’aune de Paris. Et s’aucune foisoit encontre, ses sires paieroit xl libr. de tournois, toutes les foiz que ele feroit encontre, et s’ele n’avoit signeur, ele meimes les paieroit; et si seroient ces amendes départies si comme il est dit desus. (Duplès-Agier, pp. 179–180)
Proibendo l’uso di alcuni materiali e il possesso di alcuni beni ad una determinata categoria sociale, si viene a creare una sorta di privilegio nobiliare, un diritto al lusso.30 Con la fissazione di queste distinzioni, immediatamente percepibili, il legislatore trasforma una serie di manifestazioni di benessere in elementi arbitrari che invece marcano una distinta classe sociale.31 Sul finire del Medioevo, in sostanza, il modo di vestirsi risulta un effettivo strumento politico, tenendo pur sempre in considerazione le differenze nette sul modo di vestirsi rapportate ai diversi gradini della piramide sociale.32 I capi d’abbigliamento, infatti, considerati come oggetti di rappresentazione, definiscono una gerarchia sociale; e regolare questi oggetti con leggi apposite significa regolare e categorizzare le relazioni sociali.33
Come sottolineato da Heller, la duplicità delle ordinanze rivela che effettivamente il primo tentativo di regolarizzare e controllare l’uso del guardaroba non aveva portato agli esiti sperati e che quindi la preoccupazione di dotarsi di ulteriori misure di sicurezza era di fatti ancora viva quindici anni dopo.34 Inoltre, se si mettono a confronto le due ordinanze, di Filippo III prima e di suo figlio poi, si notano differenze sostanziali. La prima inizia con alcune limitazioni riguardo i costumi a tavola e contiene soltanto proibizioni, mentre la seconda, invece, si concentra unicamente sul vestiario e contiene anche le sanzioni e gli obblighi suddivisi per categoria sociale.35 Un dato interessante riguarda l’aspetto linguistico: l’ordinanza del 1279 è stata scritta interamente in francese e ciò dimostra l’attenzione del re verso l’elemento linguistico e la 170relativa importanza sociale della comunicazione. Come per il Gouvernement, anche in questo caso ci si rivolge ad un pubblico ampio; e pertanto, l’uso del francese al posto del latino (da sempre lingua del diritto) appare necessario per assicurare una comunicazione efficiente.
Considerazioni sul vestiario appaiono quindi come parte di un sistema ben più largo, che include politica, letteratura, linguistica e sociologia.36 A questa lista vi si può aggiungere, a ragione, anche la scienza, ricordando ad esempio la nota metafora che consente di rappresentare il corpo statale con le sembianze del corpo umano.37 Nel Gouvernement viene spesso utilizzato questo artificio retorico ed il re è quindi sinonimo della testa e dell’anima di tale corpo, umano e politico, in quanto amministratore e fulcro dell’azione e possessore del potere decisionale. Oltre alla sostanza ed alla carne, va considerato anche il rivestimento, l’apparenza: come il corpo si mostra all’esterno. Ed ecco il collegamento con l’abito e con il modo di vestirsi, e quindi di apparire: ‘Le schème de l’enveloppement engage, comme on le voit, tous les états corporels et toute la physicalité chrétienne. L’anatomie du corps humain ne fait pas exception à ce schème du (re)vêtement’ (Bartholeyns, Le tiers terme, p. 129). Infatti, Henri de Mondeville, chirurgo ufficiale di Filippo IV scrive per il re un trattato medico che prende il nome di Chirurgia (tra il 1306 e il 1320), i cui primi due libri saranno poi tradotti in francese negli anni successivi.38 De Mondeville descrive alcune parti del corpo umano come dei vestiti piegati o arrotolati: si parla infatti dell’anima che si veste con il corpo, con la carne.39 Lo stesso chirurgo utilizza a più riprese questa analogia e sottolinea come la carne salvaguardi il corpo (e l’anima), proprio come fanno gli abiti:
La traduction française vers 1314 de ce traité d’anatomie donne d’ailleurs une image assez exceptionnelle (fig. 2 en annexe): celle d’un homme excorié 171qui porte sa peau comme on pouvait porter ses vêtements lors d’un voyage, si l’on en croit les initiales historiées du voyage d’Élimélek et Noémi dans plusieurs Bibles un peu antérieures. (Bartholeyns, Le tiers terme, pp. 129–130)
In conclusione, presentando questa serie di dati testuali si è cercato di mostrare la percezione dell’abbigliamento presso la corte di Francia sul finire del tredicesimo secolo, partendo da una fonte letteraria di primaria importanza come lo speculum principis di corte, il Gouvernement. In seguito, sono stati tracciati i collegamenti con fonti e testi coevi, come le ordinanze ufficiali promulgate dai re ma anche con testi collaterali, come la Chirurgia di de Mondeville o lo Speculum di Durand. Considerando questo insieme di fonti, è stato quindi possibile avere una visione abbastanza esaustiva sulla tematica del vestiario, sulle sue sfumature e sui suoi riflessi letterari; soprattutto, è stato anche possibile fornire alcuni dettagli sull’impatto sociale del modo di abbigliarsi e sul modo di regolamentarlo politicamente.
Gavino Scala
Université de Genève –
Faculté des lettres
gavino.scala@unige.ch
1 La tradizione manoscritta del Gouvernement è stato oggetto della mia tesi di dottorato: Gavino Scala, ‘La tradizione manoscritta del Livre du gouvernement des roys et des princes. Studio filologico e saggio di edizione’ (tesi non pubblicata, Università degli Studi di Siena–Universität Zürich, 2021).
2 La bibliografia su Egidio Romano e sul De regimine principum è cospicua, pertanto, oltre a Scala 2021, si rimanda a: Charles F. Briggs e Peter S. Eardley, A companion to Giles of Rome (Leiden–Boston: Brill, 2016); Roberto Lambertini, ‘Giles of Rome’, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, a cura di Edward N. Zalta (Winter 2019 Edition), <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/giles/> [ultima consultazione il 26 maggio 2023]; Gerardo Bruni, ‘Il De regimine principum di Egidio Romano’, Aevum, 6 (1932), 339–372; Noëlle-Laetitia Perret, Les traductions françaises du De regimine principum de Gilles de Rome, Parcours matériel, culturel et intellectuel d’un discours sur l’éducation (Leiden: Brill, 2011).
3 Etica, Economica, Politica, ovvero la formazione morale dell’uomo, la gestione della famiglia e l’amministrazione dello Stato.
4 Samuel Paul Molenaer, Li livres du gouvernement des rois, a XIIIth century French version of Egidio Colonna’s treatise De regimine principum (New York / London: MacMillan, 1899).
5 Cf. JONAS. Répertoire des textes et des manuscrits médiévaux d ’ oc et d ’ oïl,IRHT–CNRS, <https://jonas.irht.cnrs.fr/> [ultima consultazione il 26 maggio 2023], s. v. ‘Livre du gouvernement des rois et des princes’.
6 Sul tema dell’educazione si vedano, in particolare, i contributi di N.-L. Perret: Noëlle-Laetitia Perret, Les traductions françaises du De regimine principum de Gilles de Rome, Parcours matériel, culturel et intellectuel d’un discours sur l’éducation (Leiden: Brill, 2011); Noëlle-Laetitia Perret, ‘The Role of Pleasure in the Acquisition of Good Virtues: Giles of Rome’s idea of Education in his De regimine principum (c. 1279)’, in Pleasure in the Middle Ages, a cura di Naama Cohen-Hanegbi e Piroska Nagy (Turnhout: Brepols, 2018), pp. 203–224.
7 Per il modello latino, data la mancanza di un’edizione moderna, il testo, com’è d’uso, si citerà a partire dall’edizione del 1607: Aegidii Columnae Romani […] De Regimine Principum Lib. III (Romae: apud Bartholomeum Zannettum, 1607).
8 Per il quale si sono tenuti presente soprattutto: Perrine Mane e Françoise Piponnier, Se vêtir au Moyen Âge (Paris: Adam Biron, 1995); Michel Pastoureau (diretto da), Le vêtement. Histoire, archéologie et symbolique vestimentaires au Moyen Âge (Paris: Le Léopard d’or, 1989); Sarah Grace Heller, Fashion in Medieval France (Boydell and Brewer: Suffolk, 2007).
9 Riflessioni sull’abbigliamento da un punto di vista filosofico, sociale e storiografico e quindi sul rapporto tra corpo e vestito e tra uomo e collettività si leggono in Odile Blanc,‘Historiograpie du vêtement: un bilan’, in Le vêtement, pp. 7–33, in partic pp. 16–25.
10 Cf. Mane e Piponnier, pp. 22–28.
11 Sull’abbigliamento femminile in generale si rimanda ancora a Mane e Piponnier, pp. 96–117.
12 Cf. DMF, Dictionnaire du Moyen Français (1330–1500), ATILF–CNRS–Université de Lorraine (2020)<http://zeus.atilf.fr/dmf/> [ultima consultazione il 26 maggio 2023], s.v. ‘fard’.
13 Tale divieto, menzionato anche nel Decretum Gratiani e perciò oggetto di studi anche in termini di diritto canonico, è di origine patristica e risalirebbe a Sant’Agostino: cf. Federica Boldrini, ‘“An mulieribus licitum sit se ornare”. Female Appearance as an Emerging Object of Juridical Regulation between the Middle Ages and the Early Modern Times’, in Conduct Literature for and about Women in Italy. Prescribing and Describing Life 1470–1900, a cura di Helena Sanson e Francesco Lucioli (Paris: Classiques Garnier, 2016), pp. 207–226 (in partic. p. 208).
14 Il tema delle virtù, quelle del principe perfetto, è ovviamente centrale nell’opera, tant’è che vi è un’intera sezione (Libro I, parte II) ad esso consacrata; sul tema cf. Roberto Lambertini, ‘Tra etica e politica: la prudentia del principe nel De regimine di Egidio Romano’, Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale, III/1 (1992), pp. 77–144; Roberto Lambertini, ‘Il filosofo, il principe e la virtù. Note sulla ricezione e l’uso dell’Etica Nicomachea nel De regimine principum di Egidio Romano’, Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale, II/1 (1991), pp. 239–279.
15 Cf. Odile Blanc, ‘Vêtement féminin, vêtement masculin à la fin du Moyen Age. Le point de vue des moralistes’, in Le vêtement, pp. 243–253, in partic. p. 246.
16 Ma cf.Jonas, s.v. Miroir aux dames.
17 Durand de Champagne, Speculum dominarum, edizione critica a cura di Anne Flottés-Dubrulle et alii (Paris: École Nationale des Chartes, 2018).
18 Sull’abbigliamento del bambino durante il Medioevo si rimanda a Danièle Alexandre-Bidon, ‘Du drapeau a la cotte: vêtir l’enfant au Moyen Âge (xiiie–xve s.)’, in Le vêtement, pp. 123–168.
19 Cf. DMF, s.v. ‘mou’.
20 Cf. Félix Gaffiot, Dictionnaire Latin Français, (Paris: Hachette), 1934, s.v. ‘mollis’.
21 Cf. Mane e Piponnier, pp. 92–93.
22 Sulla funzione politica della letteratura e sulla concezione di potere espressa nel De regimine principum e in generale attraverso il genere degli specula, si vedano in particolare: Jacques Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France. xiiie–xve siècle (Paris: Gallimard, 1993); Michel Senellart, Les Arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement (Paris: Seuil, 1995); Le Prince au miroir de la littérature politique de l’Antiquité aux Lumières, a cura di Frédérique Lachaud e Lydwine Scordia, (Mont-Saint-Aignan: Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2007).
23 Gil Bartholeyns, ‘Gouverner par le vêtement: naissance d’une obsession politique’, in Marquer la prééminence sociale, a cura di Jean-Philippe Genet e Igor Mineo (Paris–Rome: Éditions de la Sorbonne, 2014), pp. 215–232; Gil Bartholeyns, ‘Le tiers terme: le vêtement et la rationalité politique du corps au Moyen Âge’, Revue des langues romanes, 122/1 (2018), pp. 125–165.
24 Cf. Bartholeyns, Gouverner par le vêtement, n. 45 per notizie più dettagliate a tal proposito.
25 Cf. ibid., p. 227.
26 Cf. Ibid.
27 Henri Duplès-Agier, ‘Ordonnance somptuaire inédite de Philippe le Hardi’, Bibliothèque de l’École des chartes, 3/5 (1853), pp. 176–181.
28 Cf. Mane e Piponnier, pp. 33–35 per una panoramica sull’uso delle pellicce durante questo periodo.
29 L’argomento è trattato e contestualizzato anche in Heller, pp. 6–8 e passim.
30 Cf. Bartholeyns, Gouverner par le vêtement, p. 228.
31 Cf. Ibid.
32 Cf. Mane e Piponnier, p. 51: spesso nei romanzi si tende a rappresentare la corte e le classe sociali ai vertici, lasciando da parte i popolani, che rappresentavano la maggioranza della popolazione.
33 Cf. Bartholeyns, Gouverner par le vêtement, p. 229.
34 Cf. Heller, p. 66.
35 Cf. Duplès-Agier, p. 177.
36 A proposito di questo sistema e dei testi che vi rientrano si veda, ad esempio, Serge Lusignan, ‘Culture écrite et langue française à la cour de Philippe le Bel’, in La moisson des lettres: l’invention littéraire autour de 1300, a cura di Hélène Bellon-Méguelle et alii (Turnhout: Brepols, 2011), pp. 31–48.
37 A tal proposito si veda, ad esempio: Gianluca Briguglia, Il corpo vivente dello Stato: una metafora politica (Milano: Mondadori, 2006).
38 Le edizioni critiche del testo latino e di quello francese sono state pubblicate da A. Bos: Alphonse Bos, La Chirurgie de maître Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel, roi de France; composée de 1306 à 1320 (Paris: Firmin Didot, 1893) e Alphonse Bos, La Chirurgie de maître Henri de Mondeville. Traduction contemporaine de l’auteur (Paris: Firmin Didot, 1897–1898).
39 Cf. Bartholeyns, Le tiers terme, p. 129.